Rimazzúu
di Maria Antonietta Novara Biagini

illustrazione di Elena Pongiglione
Col tempo c’è chi diventa nostalgico e pensa che il passato fosse migliore solo perché egli stesso era più giovane e vedeva le cose con altri occhi. Ma che i tempi fossero più dolci in molti casi è innegabile, e i ricordi della mia infanzia a Riomaggiore mi dicono che quello è stato un tempo felice. Come tutti i tempi felici, ahimé, mi accorgo di quanto fosse bello solo ora che è passato.
Il paese era costruito lungo i fianchi di un’aspra valle perpendicolare al mare. Il torrente che vi scorreva era stato ricoperto nel corso degli anni, a partire dall’Ottocento, e costituiva la strada principale del paese. Quasi tutte le case lungo la salita erano attaccate le une alle altre e si differenziavano solo per il diverso colore degli intonaci e per le finestre sfalsate mano a mano che si saliva.
La casa delle nostre vacanze apparteneva da secoli alla famiglia del nonno materno. Era situata nel centro del paese. Di fronte ad essa un grande pergolato proteggeva i tavoli del bar più importante.
Il nostro appartamento era al terzo piano ma, poiché le case erano costruite sul fianco di una valle molto ripida, le cantine e gli appartamenti al primo piano avevano una parete in viva roccia. Oltre il secondo piano un portoncino si apriva su un vicolo che si chiamava “Tra u cantu”, che era parallelo alla strada di sotto. Da questo portoncino solo una rampa di scale portava alla nostra casa. Al piano di sopra abitava una famiglia di nostri cari amici di Riomaggiore, ma qui veniva il bello: dalla loro porta di casa partiva una scala con gradini di colpo molto più alti, che conducevano ad una serie di stanze costruite nel corso degli anni dai vari proprietari nel più bizzarro caos urbanistico. Noi avevamo una stanza dove erano accatastati mobili, bauli vecchi e mille altri oggetti misteriosi, e da questa stanza alquanto buia una ripida scala di legno appoggiata ad un’apertura nel soffitto portava ad un’altra camera che sembrava aprirsi sul cielo.
Questo avveniva per quasi tutte le case del paese, poiché, avendo tutti il diritto di sopraelevazione, nessuno vi aveva rinunciato, e sopra le case era stato tutto un fiorire di altre finestre, terrazzini, comignoli, tetti, trasformati poi in epoca recente in nuovi appartamenti, unendo le varie stanze in un “puzzle” straordinario.
A differenza delle facciate principali, dipinte come in tutta la Liguria a colori vivaci, il retro delle case era, a quei tempi, ancora grezzo, e rivelava le grosse pietre di roccia scura, quasi nera, con le quali le case stesse erano state costruite. Ora anche gli stretti vicoli paralleli sono intonacati e dipinti di bianco, e non si vede più l’aspra muratura caratteristica del paese.
Riomaggiore era come un’unica famiglia. Si stava con le porte di casa aperte. La vicina di sopra faceva il minestrone e lo portava a quella di sotto. O viceversa. Il sindaco del paese, già colonnello dei carabinieri, era una figura nobile, molto alto, e con incedere marziale girava per il paese col bastone da passeggio appeso al collo, salutato da tutti con deferenza.
La vendemmia era un momento d’oro. Ricordo i “ciò”: ragazzetti che si assoldavano per portare giù le “corbe” dell’uva dai “cian”, i terrazzi orlati e sostenuti dai muri a secco.
In tutto quei muri erano lunghi, nelle intere Cinque Terre, tremilaseicento chilometri, una lunghezza che in Cina corrisponde a diecimila “li”, ossia alla lunghezza della Grande Muraglia. Con la differenza che i nostri muri erano stati edificati senza usare lavoratori forzati, ed erano invece opera di uomini e donne liberi e pacifici.
C’era un’abbondanza di nomi strani e misteriosi, dovuti ai padri che davano ai figli il nome della nave in cui erano imbarcati al momento della nascita del pargolo, oppure dei venti che rendevano più propizia la navigazione: Persia, Esperia, Giuditta, Oriente, Modesta, Selene, Geremia, Martorina, Libero. Allora non mi sembravano strani perché li associavo a gente conosciuta.
“Nuova Yorche” ricorreva spesso nei discorsi degli uomini del paese. Molti erano stati imbarcati sulle navi quando il duro lavoro nei “cian” non bastava a sostentare la famiglia. Parecchi di loro abbandonavano la nave, una volta arrivati in America, e con il duro lavoro al quale erano abituati mettevano da parte una fortuna, che consentiva loro, una volta ritornati al paese, di sposare le ragazze più giovani e belle.
Nel 1956, mentre eravamo in vacanza in Trentino, vidi la mamma e la nonna piangere ascoltando la radio che annunciava l’affondamento dell’“Andrea Doria”, pensando ai molti uomini di Riomaggiore che su di essa lavoravano, persone conosciute da anni e delle quali avevamo incontrato le famiglie pochi giorni prima.
I giovani che nascevano erano belli. Le “fantele” con gli zoccoli venivano giù in lunghe file orizzontali, tenendosi a braccetto, e dietro di loro veniva la fila dei “fanti”, i ragazzotti bulletti, anche loro con gli zoccoli. Lo zoccolare era diverso: tic-tic facevano gli zoccoli delle fantele, toc-toc quelli dei fanti. Era tutta una sinfonia di odori e rumori.
La vecchia Rimazzúu aveva inventato il telegrafo senza fili. Di finestra in finestra le comari si comunicavano le novità. Arrivava il treno e il telegrafo senza fili si attivava:
— Scia Ina, scia Ina, u l’é arrivou sö maiu. —
Allora tutti noi uscivamo di casa per andargli incontro, ma il papà, per evitare la lunga galleria del treno, saliva per la strada lungo la valle della stazione, che era situata al fondo di una valle parallela a quella dove era costruito il paese, mentre noi percorrevamo di corsa la strada principale che scendeva serpeggiando verso la galleria, e allora il telegrafo senza fili, di finestra in finestra, avvertiva:
— Scia Ina, scia Ina, u l’ha piggiou a stradda du vallun. —
E anche a papà dicevano:
— Sciu Manliu, sciu Manliu, stan andandu pa-a galleria. —
Allora il papà cambiava strada per venirci incontro. Ma anche noi, allertati dalle vedette, avevamo cambiato strada.
Questo successe due o tre volte, finché papà ci ingiunse, attraverso “radio finestra”, di tornare a casa, in modo da poterci finalmente incontrare.
Ricordo la moglie del pescatore che veniva a suonare alla porta per vendere un’aragosta viva appena pescata. Risparmiamo ai lettori la descrizione truculenta di quello che succedeva alla povera aragosta. Noi bambini e la mamma andavamo a nasconderci per non assistere alla bollitura, mentre la nonna, assolutamente disinvolta, preparava il lauto pranzo. Un giorno incappammo in un’aragosta vendicativa. Una volta portata in tavola, mentre ci preparavamo a gustare la leccornia, un bicchiere scoppiò, senza apparente motivo. Minuti frammenti finirono dentro l’aragosta, recuperarli uno ad uno neanche a pensarci, e dovemmo gettar via la succulenta pietanza.
Tutti ci invitavano, e una volta, quando avevo circa dodici anni, ero andata con la nonna di famiglia in famiglia. Non andare da tutti quelli che invitavano sarebbe stata un’offesa e avrebbe suscitato rivalità e gelosie. Ci offrivano “ün guttin de sciacchetrà refursà, che u fa ben”. A forza di bicchierini così rinforzati, tornata a casa, non sapevo più come mi chiamavo.
Quando ero molto piccola e andavamo alla spiaggia della stazione (allora molto grande, oggi completamente scomparsa); tutta la famiglia e i loro amici mi stavano intorno e mi dicevano di scavare alla ricerca di tesori. Quando avevo scavato una bella buca, ci facevano cadere di nascosto un anello o un orologio. Io, tutta contenta, incameravo il ricco bottino e poi, quando mi dicevano di restituirlo, non capivo perché dovessi rinunciare al mio tesoro. Vatti a fidare dei parenti.
“Creola, dalla bruna aureola …….”. Attraverso le finestre aperte si udiva cantare, al bar sottostante, il primo juke-box arrivato in paese, con una ristrettissima scelta di canzoni già allora largamente datate e appartenenti ad un’altra epoca.
Nei primi anni della mia infanzia, la mia famiglia non possedeva l’automobile. né d’altra parte avremmo potuto usarla perché le nostre vacanze si svolgevano a Riomaggiore, la più orientale delle Cinque Terre, e a quell’epoca i cinque borghi erano raggiungibili solo in treno o a piedi lungo i sentieri che, durante la guerra, erano serviti alle donne rimaste per andare nei paesi dell’Appennino a procurarsi farina e generi alimentari non reperibili nei borghi lungo la costa, isolati da tutto.
Uno dei treni che facevano servizio fra Genova e le Cinque Terre era la mitica “Littorina”, dalle linee modernissime (i treni veloci della Germania ne sono la copia fedele), marrone con in basso una riga rossa. Un anno, al ritorno a Genova dalle vacanze passate a Riomaggiore, nella vettura dove stavamo con la nonna e la mamma, scoppiò un incendio. Eravamo sotto una galleria, ma vicino a una stazione. Io avevo circa cinque anni, la gente fuggiva e nessuno si curava delle due donne con i bambini. Per fortuna un signore di Riomaggiore, che era salito con noi sul treno, non vedendoci in salvo sul marciapiede, si fece largo nella calca e ci aiutò a metterci in salvo. Non ho un particolare ricordo drammatico della vicenda, rammento solo il buio e la folla, ma la nonna e la mamma, negli anni seguenti, raccontavano ancora con paura questo avvenimento. Oggi la “littorina” non esiste più: forse è stata epurata per via del nome.
Ricordo le donne vestite di nero e spesso scalze che percorrevano la strada principale del paese, dedite alle loro faccende; si fermavano in crocchi a chiacchierare tra loro. I richiami si rincorrevano da una finestra all’altra, per ricordare un acquisto, un messaggio per un’amica, per informarsi della salute di un parente, un avviso da parte di altre amiche. Poiché nelle case non vi era il telefono, quello era il modo per comunicare. Tutti sapevano i fatti di tutti, ma era anche la maniera per tenere unita e solidale la comunità.
Ricordo la processione della Madonna. A tutte le finestre venivano esposti tappeti damascati e alle persiane si appendevano i lumini di carta variopinta con dentro una candela accesa, detti “lumi veneziani”. Un anno il vento fece prendere fuoco al lume, le fiamme si propagarono alle persiane e se non ci fosse stato il tempestivo intervento della mamma e della nonna, le conseguenze avrebbero potuto farsi pericolose.
In paese non c’era il cinema. Ricordo come in un sogno la sera che, nella piazza della chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, venne proiettato il film “Giovanna d’Arco” con Ingrid Bergman. Fu un evento memorabile. Un grande lenzuolo bianco venne appeso alla facciata della parrocchia; sedie di legno, forse le stesse della chiesa, disposte sulla piazza, accolsero i numerosi spettatori. Io ero molto piccola, ma ricordo ancora la gente e il luogo illuminati dalle fiamme del rogo della Santa provenienti dallo schermo improvvisato.
Un altro evento memorabile fu l’arrivo alla stazione, tramite ferrovia, di un grosso motocarro nero che doveva servire per agevolare il trasporto dell’uva e del vino da spedire ai vari clienti. I primi giorni in cui il fragoroso mezzo meccanico percorse la strada principale del paese era costantemente inseguito da un codazzo di ragazzini urlanti.
Ricordo il muggito triste dei vitelli legati fuori della macelleria, in attesa di essere trasformati in bistecche per il desco delle famiglie. Il momento era drammatico, per loro, ma non per me, perché non collegavo la loro presenza alle bistecche, e invece aumentavo le mie conoscenze zoologiche, essendo quelli i primi vitelli che vidi in vita mia.
La vendemmia era invece un periodo di festa. Per tutto il paese c’era un’atmosfera elettrizzata; l’odore dell’uva e del mosto era ovunque. Dappertutto venivano appesi alle porte delle cantine grappoli e foglie d’uva. Gli uomini scendevano a valle recando sulle spalle grosse gerle ricolme d’uva, soprattutto quella della qualità “Bosco”, dagli acini piccoli, quasi color del bronzo tanto il sole l’aveva maturata e così dolce da far bruciare la gola.
Tutte le famiglie producevano il loro vino. Noi andavamo ad assistere alla vendemmia nella cantina dei nostri amici su in un posto che si chiamava “Locca”. La moglie Elena, in un basso bacile, schiacciava l’uva con i piedi camminando in circolo. Natale, il marito, era immerso fino al petto in un grosso tino e faceva lo stesso lavoro con una maggior quantità di uva. Il vino che ne usciva era meraviglioso.
Sulle “ciazzee”, le terrazze, era invece stesa ad appassire l’uva che sarebbe servita per fare lo sciacchetrà, il mitico vino chiamato dai locali “refursà”. Una bottiglia di quel nettare era il regalo più prezioso che si potesse fare o ricevere.
Un ultimo ricordo è legato al suono delle campane che scandivano il passare delle ore e, dall’alto del paese, erano testimoni delle fede profonda di quelle popolazioni che in ognuna delle Cinque Terre — Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore — avevano voluto costruire sulle vette più alte e più suggestive un santuario dedicato alla Madonna, alla quale si rivolgevano fiduciose in tutti i momenti tristi e felici della loro esistenza.
Ed oggi? Cinquant’anni dopo, l’odore del vino che accoglieva i visitatori è quasi del tutto scomparso. Non si sentono più gli zoccoli né la dolce cadenza del dialetto del paese, ma voci straniere di branchi di marciatori armati di racchette da sci che arrancano senza posa, su e giù, su e giù, e se si fermassero bloccherebbero il movimento lungo gli stretti sentieri. Ma come si fa a non essere d’accordo con i cambiamenti avvenuti in nome della tutela dell’ambiente, del “progresso” e soprattutto del benessere?
Un’ultima considerazione. Oggi, avere una casa delle Cinque Terre è diventato uno “status symbol”. Ma la frequentazione di questo paradiso non dovrebbe essere solo fine a se stessa. Bisogna far conoscere a chi viene qui la storia e la vita di queste popolazioni che hanno strappato a una natura ostile di valli scoscese e torrenti impetuosi le terrazze ove coltivare la vigna e le case dove crescere le loro famiglie.
Oggi questi magnifici borghi non potrebbero più sorgere. Violentare la natura delle montagne per terrazzarle verrebbe considerato un delitto, ancor peggio ricoprire i torrenti, e tutte quelle case addossate le une alle altre, con sopraelevazioni, pareti in roccia, massa di pietra visibile fin da lontano dal mare, sarebbero considerate un enorme eco-mostro da far saltare con la dinamite. Fortunatamente gli ambientalisti sono arrivati troppo tardi.
========================
Il brano qui pubblicato fa parte della raccolta di racconti di Maria Antonietta Novara Biagini L’ALBERO SECCO, pubblicata da Fede & Cultura di Verona, disponibile su ordinazione in libreria, oppure on line, CLICCANDO QUI
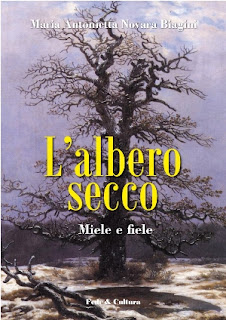
Recensione
Quarantasei testi, uno al giorno per un mese e mezzo. Per ridere delle miserie del potere ottuso, che pretende tutto decidere, giudicare e governare; per farsi beffe del darwinismo, che pretende l’uomo “discendente” da “antenati” comuni alle scimmia e non si rende conto che alle scimmie sta tornando. In questo volume si possono trovare spassosi esempi di poesia moderna e delle molte idiosincrasie che rendono ridicola l’umanità; ma non solo, la lettura di quest’opera serve anche a far sorridere e commuovere pensando alla figura di Padre Pio e ai ricordi delle proprie radici.
L’Autore
Maria Antonietta Novara Biagini è nata a Genova. Ha frequentato fino alla maturità classica l’Istituto delle Suore dell’Assunzione. Si è poi iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova, senza però impegnarvisi al punto da giungere al conseguimento della laurea, preferendo occuparsi della sua famiglia invece di abbandonarla in mano a truppe mercenarie. Nello stesso tempo ha potuto sviluppare i propri interessi culturali e le proprie curiosità, anche attraverso viaggi in quasi tutte le parti del mondo, approfondendo e fortificando una formazione cattolica e controcorrente. Su istigazione del Professor Piero Vassallo, emerito di Filosofia della Facoltà teologica dell’Italia settentrionale, ha cominciato a scrivere saggi e racconti, e da allora non si è più fermata. È sposata da molti anni col Professor Emilio Biagini, ordinario in un’università periferica. Con riferimento al racconto “Rimazzúu”, va ricordato che la famiglia materna dell’autrice, Bonanni, è appunto di Riomaggiore (SP), dove l’autrice stessa, durante l’infanzia, usava trascorrere le vacanze. Poiché in paese vi sono molte famiglie con lo stesso cognome, per distinguere le stirpi si ricorre ai soprannomi. La famiglia della madre è quella “dei Fabin”.





1 commento su “RIMAZZUU – ricordi di Maria Antonietta Novara Biagini”
Grazie, sicuramente tornerò. Geremia Barese