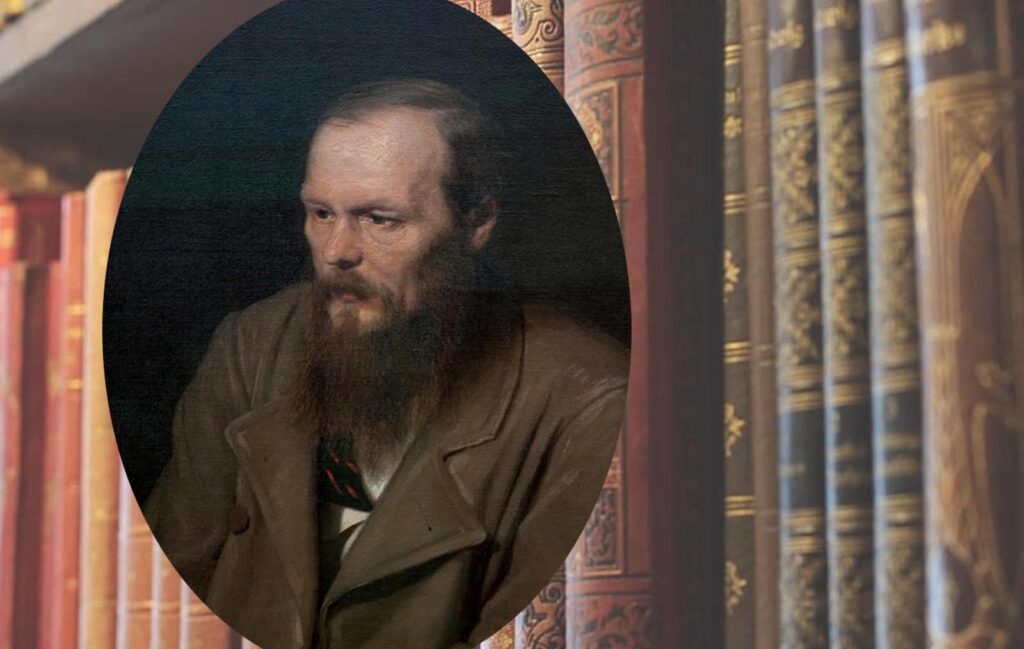“Oggi, 22 dicembre, siamo stati condotti sulla piazza Sëmenov. Lì è stata letta a tutti noi la sentenza di condanna aa morte, poi ci hanno fatto accostare alla croce, hanno spezzato le spade al di sopra delle nostre teste e ci hanno fatto indossare l’abbigliamento dei condannati a morte (delle camicie bianche). Dopodiché tre di noi sono stati legati al palo per l’esecuzione della sentenza. Io ero il sesto della fila e siccome chiamavano a tre per volta io facevo parte del secondo terzetto e non mi restava da vivere più di un minuto. Mi sono ricordato di te, fratello, e di tutti i tuoi; nell’ultimo istante tu, soltanto tu, occupavi la mia mente, e soltanto allora ho capito quanto ti amo, fratello mio carissimo! Ho fatto anche a tempo ad abbracciare Plešceev e Durov, che mi stavano accanto, e a dir loro addio. Finalmente è stato dato il segnale della ritirata, quelli che erano legati al palo sono stati ricondotti indietro e ci è stato letto il proclama con cui Sua Maestà Imperiale ci donava la vita. Quindi è stata data lettura delle condanne autentiche”[1].
Queste parole, sobrie nei dettagli, furono scritte da Dostoëvskij al fratello il 22 dicembre 1849, appena dopo l’esperienza terribile della condanna a morte revocata all’ultimo momento che segnò il resto della sua esistenza.
Sono parole essenziali che dipingono una frattura nella mente di Dostoëvskij[2]. Spesso se ne ammira il talento nel saper descrivere con estrema efficacia gli angoli più bui del mondo interno dell’uomo, nelle sue luci più fosche, e si dimentica che la finzione letteraria affondava in un’intensa sofferenza dai risvolti anche fisici.
Molti dei suoi scritti, infatti, raccontano, con un talento letterario singolare, un tentativo di riparazione della propria mente che illumina, in modo universale, gli effetti distruttivi del peccato originale sull’uomo.
Dostoevskij fu arrestato per sovversione il 23 aprile 1849 e condannato alla pena capitale il 16 novembre. Graziato con commutazione della pena il 19 dicembre, non ne fu informato e venne comunque portato al patibolo il 22 nel cortile del carcere in gruppi da tre persone per l’esecuzione perché così richiedeva la procedura. I primi tre furono uccisi subito, il gruppetto seguente – il suo -, fu graziato. Questa messa in scena spaventosa era prevista dalla legge[3]. Fu condannato ai lavori forzati che scontò tra il 1850 e il 1854, quando fu liberato.
Quello vissuto da Dostoevskij è il momento di una devastazione totale. Sperimenta la propria inermità fino al limite in cui l’altro ha in suo potere l’esistenza e, come in un chiaroscuro angosciante e freddo, si rende conto – con una terribile certezza – che da lì a un attimo non ci sarà più.
È il momento del collasso, del prosciugamento della mente. Una specie di bomba al napalm che brucia una parte viva del cervello. Qualcosa che attraversa tutto l’essere e non si può conoscere nell’istante in cui lo si vive perché altera la mente, depositando nel corpo una memoria purulenta.
Da quell’attimo la vita coincide con la tensione che si è impadronita del corpo, ne appare l’unica dimensione della vita e, in effetti, rilascia l’ultimo ricordo in cui corpo e mente si fondono per evitare la dissociazione.
Se, come Dostoevskij, si ha la ventura di sopravvivere a un’esperienza così estrema, a un tale strazio, non ci sarà più la vita nella sua pienezza, ma unicamente la sopravvivenza.
La vita assume i contorni di un paesaggio devastato nel quale si è alla ricerca di una quiete, di quella particolare sensazione sperimentabile quando il sole sta per sorgere e che, anche se la sua luce si riflette solo nelle pozzanghere, sembra far intravedere una presenza che infonde una pace più potente di tutte le altre.
Ritornato dalla prigionia, Dostoevskij riprende a pubblicare. Il bisogno di espellere l’orrore accumulato si esprime con la necessità di manifestarlo, la condivisione di una ricerca insonne del perché è potuto accadere ciò che è successo.
È il terreno fertile in cui può prolificare una dipendenza, la necessità, cioè, di riprodurre il momento traumatizzante nell’inutile tentativo di esorcizzarlo e con l’illusione che l’ennesima ripetizione possa essere quella risolutiva.
Si deve fare i conti con una grande sofferenza: l’impossibilità di tollerare che la volontà, questa dimensione così qualificativa dell’essere umano, possa svolgere una funzione liberatoria, di guida e controllo di sé; ma è un’amara illusione, perché il trauma ne ha intaccata intimamente l’essenza.
… infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio (Rm. 7, 19).
Dostoëvskij percorrerà questa via crucis, cadendo nel vortice del gioco d’azzardo e ne sarà dipendente per quasi dieci anni dal 1862 al 1871. Un periodo devastante.
Uno dei primi documenti pervenuti in cui riferisce di aver giocato è una lettera alla sorella della prima moglie del 1° settembre 1863.
La lettera è una testimonianza essenziale della sua sofferenza mentale perché l’autore sembra osservare se stesso in modo oggettivo e a un certo momento scrive alla sua interlocutrice che il segreto di vincere […] è terribilmente semplice e stupido: consiste nel controllarsi continuamente a prescindere dalle fasi di gioco, nel non accalorarsi. Tutto qua: in questo modo è impossibile perdere, si è sicuri di vincere[4].
L’osservazione di Dostoevskij sembrerebbe indurre l’idea che quella che oggi è definita ‘ludopatia’, possa essere vinta con la volontà, ma non dobbiamo farci ingannare dal termine ‘controllo’. Occorre prendere le distanze dalle facili associazioni e cercare di scoprire cosa racchiuda in sé l’affermazione riportata nella lettera.
Il Giocatore[5] fu scritto nel 1866 e nella sua genesi drammatica ha lo stigma delle conseguenze del gioco.
Le difficoltà economiche nelle quali si dibatteva Dostoëvskij lo avevano spinto ad accettare un contratto capestro da parte dell’editore Stellovski che gli imponeva, entro il termine del mese di ottobre, la pubblicazione di un romanzo, pena la rinuncia degli interi diritti sui libri che avrebbe scritto in seguito.
Dostoevskij riuscirà ad assolvere, in ultimo e con non poca fatica, al suo impegno.
L’aspetto economico, per quanto importante, non sarebbe interamente giustificativo se non si considerasse anche lo stato mentale ed emotivo nel quale viveva in quegli anni e che è possibile cogliere dall’insieme della produzione letteraria.
Dostoevskij compie attraverso i libri scritti in quegli anni un personalissimo percorso tra i demoni della sua anima; ripesca nel suo animo travagliato gli elementi per comprendere, rimodellare gli aspetti più tormentati che avevano segnato la sua vita.
Tra il 1860 e il 1862 pubblica Memorie dalla casa dei morti, un’intensa descrizione di carattere autobiografico di cosa può comportare per un uomo l’abbruttimento in una situazione sub umana e come, in un clima di tolleranza religiosa, la semplicità del Vangelo possa presentarsi come un cammino di redenzione.
Contestualmente, sempre due anni dopo il ritorno dalla deportazione in Siberia, nel 1861, aveva pubblicato Umiliati e Offesi. Nel romanzo l’autore mette in scena la lotta tra luce e tenebra, in cui le protagoniste femminili, maledette dai propri padri, sono spesso vittime d’individui senza scrupoli. Quello che colpisce nel romanzo è la capacità di Dostoevskij di scavare nei sentimenti profondi dei protagonisti, portando il lettore quasi a toccare con mano relazioni umane di grande tragicità.
Nel 1864 pubblica Memorie del sottosuolo. Il libro è diviso in due parti. La prima è occupata dalla presa di distanza nei confronti della società culturale del suo tempo che ha perso il senso del proprio cammino.
Nella seconda si avvia quella ricerca dell’uomo nell’uomo, l’uomo che non gioca più tutta la sua esistenza sulla dimensione sociale, ma riscopre la vita interiore. La vita dell’anima, non la vita soltanto.
“Sono un uomo malato… Sono un uomo cattivo[6]”, dirà il protagonista.
Il Giocatore fu scritto nel 1866. È anche il momento della pubblicazione di Delitto e Castigo con la straordinaria ricostruzione della solitudine di Raskol’nikov, l’uomo moderno spinto all’esasperazione di se stesso perché deve dimostrare di essere un uomo “eccezionale”, aldilà del bene e del male. In bilico, tra la paura e il bisogno di affermazione di sé a scapito di tutto. Nichilismo disperato e ricerca di senso.
Tre anni dopo, nel 1869, vedrà la luce l’Idiota, definito un frammento di Cristo, romanzo della bontà (o bellezza) disarmata che sembra soccombere al male imperante, ma rimane comunque come unica speranza. Un cammino difficile quello di raffigurare un uomo assolutamente buono. Niente, secondo me, può essere più difficile di questo, al giorno d’oggi, come scriverà a un amico nel dicembre del 1867[7].
Qualche anno dopo troviamo una singolare eco di queste parole nella riflessione lasciata da una compagna di Teresa di Lisieux che aveva cercato di essere buona per un solo giorno, rendendosi conto, però, di quanto fosse impegnativo…
In mezzo a questo tormento il Giocatore fu scritto freneticamente da un Dostoevskij incalzato dai debiti, tormentato dagli attacchi di epilessia, attratto dal canto di sirena della roulette.
Siamo di fronte a una descrizione precisa e sofferta di quanto una dipendenza, in questo caso il gioco, possa soggiogare l’anima e la mente di un essere umano.
Una narrazione serrata di come un’esperienza traumatica nella quale gli elementi psichici frantumati dopo che il mondo interiore è deflagrato, diventano degli organizzatori mentali di comportamenti disfunzionanti, come ben descrive Dostoevskij.
Erano le dieci e un quarto ed io entravo nel casinò animato da una speranza così salda e allo stesso tempo in preda a una tale esaltazione quale ancora non avevo mai provato.
[…] Ero come preso dalla febbre e nell’eccitazione ho puntato tutto il mio mucchio di denaro sul rosso e… improvvisamente sono tornato in me! E soltanto in quel momento, per tutta la serata e per tutta la durata del gioco, ho sentito un brivido di terrore corrermi per la schiena mentre mi prendeva un tremito alle mani e ai piedi. In un attimo mi sono reso conto con terrore cosa significava per me perdere: insieme a quell’oro puntavo tutta la mia vita! «Rouge!» ha gridato il croupier e io ho tirato un sospiro di sollievo mentre un formicolio di fuoco mi correva per tutto il corpo. […] Allora mi ha preso una specie di furore e ho puntato sulla prima dozzina i duemila fiorini rimasti, così a casaccio, senza stare a calcolare! Ricordo di aver vissuto un istante di attesa spasmodica, simile forse a quello che deve aver provato madame Blanchard quando a Parigi precipitò dall’aerostato a terra. «Quatre!» ha gridato il croupier, e così in tutto, con la posta precedente, mi trovavo possessore di seimila fiorini. Avevo ormai l’aria di un trionfatore, non avevo più assolutamente paura di nulla e ho gettato quattromila fiorini sul nero. […] Sono convinto che qui, almeno per metà, c’era di mezzo la mia vanagloria; mi era venuta una gran voglia di sbalordire gli spettatori col gran rischio che correvo, e del resto ricordo chiaramente che – strana sensazione! – al di là di ogni sollecitazione della vanagloria, mi sono sentito ad un tratto totalmente dominato da una folle sete di rischio. Può darsi che l’animo, dopo aver provato tante sensazioni, non solo non se ne sazi, ma al contrario ne ricavi un’eccitazione che lo spinga ad esigerne sempre di nuove e di più forti, fino a restarne definitivamente spossato. (Il giocatore, pp. 113-115).
Il corpo diventa il campo di battaglia precipuo, surclassando la capacità della mente di mantenere l’armonia e la guida della persona. Dostoëvskij rende bene le sensazioni che s’impadroniscono di lui: febbre ardente, soffio freddo, tremito, senso di vertigine, spossatezza. Se da una parte l’esistenza è percepita come un vortice di sensazioni estreme, dall’altra parte si è come spinti a dover costantemente affrontare un rischio, a soggiacere a vertigini tremende e la pace, o meglio una paralisi dell’anima, si raggiunge solo nell’osservare la pallina che gira. Quasi un corpo a corpo, un colloquio muto, per aggirare e sopraffare quel destino che ci ha ucciso.
Un sogno breve, destinato alla delusione perché il risveglio è la sensazione umiliante di non poter ristabilire sicurezza e controllo.
Credo che in poco più di cinque minuti mi sono trovato tra le mani qualcosa come quattrocento federici. A questo punto avrei dovuto andarmene, ma a un tratto ho provato dentro di me una strana sensazione, la voglia come di sfidare la sorte, di darle uno schiaffo o di mostrarle la lingua. Ho puntato la massima puntata concessa, di quattromila fiorini, e ho perduto; allora mi sono infervorato, ho tirato fuori tutto ciò che mi era rimasto, ho ripetuto la stessa puntata e di nuovo ho perduto, dopodiché mi sono allontanato dal tavolo come stordito. (Il giocatore, pag. 22).
Dostoevskij descrive con efficacia che la vita viene a coincidere con una specie di esaltazione paralizzata. Non si vive delle realtà vive, ma di una realtà bloccata che occupa veglia e sonno in un’ossessione spasmodica.
Oh, sento dentro di me un presentimento che non può non realizzarsi! Ora ho quindici luigi e ho cominciato con quindici fiorini! Se solo cominciassi con cautela… ma possibile, possibile che io sia ancora come un bambino! Possibile che non capisca che sono un uomo completamente perduto! Ma… perché poi non potrei risorgere? Sì! Basta essere paziente e calcolatore almeno una volta nella vita, ed ecco tutto! Basta almeno una volta non perdere il dominio di sé e in un’ora sola posso cambiare tutto il mio destino! L’importante è il dominio di sé. Basta solo che mi ricordi che qualcosa di simile mi è successo sette mesi fa a Rulettenburg, prima della mia perdita definitiva. Oh, quello è stato un bell’esempio di risolutezza! Quella volta avevo perduto tutto, tutto… sono uscito dal casinò, e a un tratto mi accorgo che nel taschino del panciotto c’è ancora un fiorino dimenticato. «Ah, dunque ci sarà ancora da cenare!» ho pensato fra me. Ma poi, dopo aver fatto un centinaio di passi, ci ho ripensato e sono tornato indietro. Ho puntato quel fiorino sul manque (quella volta ero fissato sul manque), e davvero debbo dire che c’è qualcosa di particolare nella sensazione che provi quando, solo in terra straniera, lontano dalla patria e dagli amici, senza neanche sapere quel che mangerai domani, punti l’ultimo fiorino, proprio l’ultimo! Ho vinto, e venti minuti dopo uscivo dal casinò con centosettanta fiorini in tasca. È un fatto! Ecco cosa può significare certe volte l’ultimo fiorino! E cosa sarebbe successo se quella volta fossi stato vile e non avessi osato?… Domani, domani tutto finirà! (Il giocatore, pag. 144).
Dostoevskij deve aver masticato molto l’immaginario del giocatore; in una lettera del settembre 1863, sembra possedere già la chiave del romanzo:
La nota caratteristica in lui è che tutti i suoi succhi vitali, le sue forze, la sua turbolenza, il suo ardire mettono capo alla roulette. Egli è un giocatore, ma non un semplice giocatore (…). Egli è nel suo genere un poeta, ma egli stesso si vergogna di questa poesia, perché sente profondamente la sua bassezza, anche se la necessità del rischio lo nobilita ai suoi stessi occhi (…). Se la “Casa di morti” ha richiamato su di sé l’attenzione del pubblico come rappresentazione degli ergastolani che nessuno aveva rappresentato con tale evidenza prima, questo racconto richiamerà immancabilmente su di sé l’attenzione come evidente e minuta rappresentazione del gioco della roulette (…). La “Casa di morti” è pur riuscita interessante. E qui si tratta della descrizione di una specie di inferno, di una specie di “bagno” penale[8].
Il gioco, dunque, è un inferno, un bagno penale nel quale, chi ne rimane prigioniero non riesce a patteggiare con l’aspetto precipuo della realtà: il senso del limite.
Non può farlo perché le circostanze tragiche della vita l’hanno portato aldilà del limite e la sua condanna, perché tale è la situazione di colui che subisce un trauma, è il tentativo destinato al fallimento di riattraversare il fiume del limite e riposizionarsi nella vita.
L’aspetto tragico di questo tentativo è che viene cercato, come ben descrive Dostoevskij, attraverso la sensazione del precipitare, della pallina nella roulette, dell’aerostato e … del cappello.
«Vede quella grassa baronessa?» ha esclamato Polina. «È la baronessa Wurmerhelm, arrivata qui solo da tre giorni. Vede, quello è suo marito: quel lungo, asciutto prussiano con un bastone in mano. Si ricorda come ci osservava l’altro giorno? Be’, adesso vada, si avvicini alla baronessa, si tolga il cappello e le dica qualcosa in francese.» «E perché?» «Lei ha giurato che si sarebbe buttato giù dallo Schlangenberg, lei giura adesso di esser pronto a uccidere se io gliel’ordinerò. Invece di tutti questi ammazzamenti e tragedie ho voglia soltanto di divertirmi un po’. Vada senza fare tante discussioni. Mi è venuta voglia di vedere come il barone la picchierà con quel suo bastone.» «Lei mi sfida; crede dunque che non lo farò?» «Sì, io la sfido. Vada dunque, giacché io lo voglio.» «E va bene, andrò, anche se si tratta di una sciocca fantasia. (Il giocatore, pag. 34).
Scrivere Il giocatore non fu ancora il passaggio decisivo per lasciarsi alle spalle la dipendenza dal gioco e le fratture dell’anima.
Ci vorranno ancora anni di meditazione (e di grandi romanzi) per raggiungere una certa pace. Un ‘certa’ pace, perché la pace, per chi subisce un trauma, è una faticosa convivenza con una sofferenza a volte invisibile e persistente, un equilibrio costruito ogni giorno tra vivere e sopravvivere.
Nell’agosto 1867 scriveva al critico Majkov: Passando non lontano da Baden, pensai di tornarvi. Mi tormentava un pensiero seducente: sacrificare 10 luigi d’oro, e forse vincere più di 2.000 franchi (…). Il peggio è che a me anche prima era capitato di vincere qualche volta. E ancor peggio è che la mia natura è vile e troppo appassionata: dovunque e in tutto io vado fino all’estremo limite, durante tutta la vita ho oltrepassato i limiti. E un demone s’è subito fatto gioco di me: in circa 3 giorni ho vinto 4.000 franchi, con straordinaria facilità. Adesso vi lascio immaginare che cosa rappresentava ciò per me: da un lato questa vincita facile (…). Dall’altro i debiti (…). Infine, in terzo luogo, e più importante di tutto, il gioco stesso. Voi sapete come attiri. No, ve lo giuro, non è soltanto l’avidità di lucro, quantunque a me anzitutto occorresse il denaro per il denaro (…). Arrischiai ancora e perdetti. Puntai fino all’ultimo quattrino, tremando di febbre; perdetti. Puntai i vestiti. Anna impegnò tutto il suo (…). Infine, basta, tutto era perduto[9].
In questa lettera troviamo un’espressione fondamentale: basta, tutto era perduto.
È l’attimo in cui, al patibolo, la sua mente si riposa nel pensiero (e nell’amore) del fratello. E’ il momento dell’abbraccio al compagno di sventura.
Il momento in cui la grazia ricevuta, lo segnerà come un demone terribile perché ha sperimentato la sua vita in balia, ingovernabile.
Il demone tornerà con le sembianze del gioco, dimensione a cui non si riesce a resistere perché è sfida alla fortuna, al caso.
Se la scrittura del Giocatore, anche per le particolari circostanze in cui fu elaborato, non ebbe di per sé un effetto catartico è pur vero che fotografa una condizione grave che sembra assorbire ogni aspetto della vita.
Un processo di guarigione era in atto, sebbene lento come si può evincere dal Diario e dalle lettere della seconda moglie.
Due anni dopo, all’inizio del gennaio 1868, in due lettere[10] al critico Majkov e alla nipote Sofia, troviamo testimonianza di un pensiero terapeutico coltivato ‘da anni’ (come scrive Dostoëvskij): descrivere una natura umana pienamente buona.
Cioè, immaginare come possibile una natura umana che non sia entrata in contatto con il male (con il trauma).
Dosto3vskij dovrà ancora penare prima di comprendere l’illusione, destinata alla follia, del totalmente buono. L’uomo è segnato dal peccato originale e, benché redento, ne sopporta la pena.
Occorrerà tutto il resto della sua non lunga vita per approdare alla pace che solo l’accettazione mite della Croce può offrire.
Dostoevskij smetterà di giocare nel 1871, due anni dopo aver pubblicato l’Idiota, tutto sembrava come prima, anche la famosa lettera alla moglie[11] in cui dice che è avvenuto un cambiamento (ma quante volte l’aveva già pronunciata quella frase!).
È un passaggio cruciale sul quale molti hanno riflettuto senza riuscire, sembra, ad arrivare a una comprensione solida di ciò che ha determinato l’abbandono del gioco da parte dello scrittore.
In questa lettera compare però un elemento nuovo: il sogno del padre.
Non è del tutto convincente l’ipotesi di Freud[12] che Dostoëvskij fosse sotto l’effetto del senso di colpa per aver desiderato l’uccisione del proprio padre. Ogni elemento di un sogno rappresenta una parte della psiche del sognatore, dell’anima, e, forse, quest’immagine del padre ha la funzione di mettere in guardia, di isolare, la tentazione del nichilismo, del venir meno della Fede nel contesto di situazioni terribili, dell’inganno sempre in agguato.
Convivere con il trauma comporta tollerare la frantumazione interiore. Il gioco soffocava Dostoëvskij fino al momento in cui, dopo aver elaborato, con l’Idiota, la possibilità del bene assoluto riconosce, attraverso la follia a cui va incontro il principe Myskin, che l’antidoto è riconoscere il limite.
Questo passaggio non coincide con la guarigione, ma con un’accettazione più serena della vita.
Il limite angoscia perché ricorda il trauma. Come abbiamo visto Dostoëvskij s’illudeva di poter controllare il gioco; il periodo di riflessione tra la pubblicazione dell’Idiota e la lettera alla moglie del 1871 testimoniano un mutamento, un passaggio alla capacità di tenere in equilibrio angeli e demoni nella propria anima frantumata.
Aleksej Ivanovič è il nome del protagonista del Giocatore, Aleksej Fëdorovič sarà anche il nome di uno dei protagonisti dei Fratelli Karamazov, il testamento di Dostoëvskij.
Aleksej Ivanovič è lo specchio di un’anima, di un mondo interiore, prigioniero del bagno penale della dipendenza (non solo del gioco).
Un inferno senza via di uscita, senza neppure una debole luce.
In Aleksej Fëdorovič, l’ultimo dei suoi grandi personaggi, possiamo intravedere l’approdo del tumulto dell’anima di Dostoevskij. Non più la vertigine della dipendenza che illude, ma neppure l’illusione del totalmente buono, destinato, però, alla follia.
La via d’uscita sarà la sofferta serenità del cammino quotidiano della bontà disarmata, tra buio e luce.
Negli anni dell’estremo smarrimento di sé, Dostoëvskij ebbe modo di ammirare a Basilea il dipinto da Hans Holbein il Giovane il corpo di Cristo morto nella tomba (1521). Davanti a quel quadro ebbe un’incisiva intuizione e consapevolezza dei propri sentimenti, delle proprie emozioni e, forse, dei moventi del proprio comportamento[13].
Il Cristo di Holbein rappresenta l’estremo limite dell’umanità, là dove l’uomo entra nella putrefazione della carne, al punto che ci si domanda se Cristo è ancora Dio? L’apparenza, l’ingannatrice per eccellenza, lancia la sua ultima trappola, quella potenzialmente definitiva.
La fine di tutto.
Nell’Idiota, il romanzo che anticipa di lì a poco la conclusione del periodo di massimo stordimento, Dostoëvskij farà dire al protagonista «Mi piace guardare quel quadro» mormorò Rogožin dopo un breve silenzio, come se avesse dimenticato nuovamente la sua domanda. «Quel quadro!» esclamò d’un tratto il principe preso da un pensiero improvviso. «Quel quadro! Ma quel quadro potrebbe anche far perdere la fede a qualcuno!» «Si perde anche quella» confermò inaspettatamente Rogožin[14].
Qui prende la parola il suo dramma profondo perché nel Cristo di Holbein vede se stesso o meglio come avrebbe potuto sentirsi una parte di sé nel momento in cui la vita gli stava per essere tolta.
Tutta l’angoscia vissuta è ben descritta da queste parole di un altro protagonista dell’Idiota, Ippolit, che riandando ai momenti della passione di Cristo, afferma Le persone che circondavano il morto, che non appaiono nel quadro, quella sera dovevano essere in un terribile stato di ansia e turbamento che aveva distrutto tutte le loro speranze e la loro fede in un colpo solo. Forse si separarono oltremodo impauriti anche se portavano dentro di sé un pensiero grandioso che mai niente avrebbe strappato loro. E se il Maestro avesse visto l’immagine del suo cadavere alla vigilia dell’esecuzione, sarebbe salito sulla croce e sarebbe morto così? È una domanda che ti viene spontanea, quando contempli quel quadro[15].
La grandezza di Dostoëvskij sta nell’aver tollerato di convivere con questa domanda. I romanzi successivi saranno la continua rielaborazione della coesistenza sedimentata dentro di lui di due anime: il mite assoluto e l’omicida (il principe e Rogozin).
La dipendenza del gioco forse non deriva dal fatto che il giocatore continua a giocare a causa di un senso di colpa[16] che deve essere espiato tramite la perdita. Il giocatore patologico non desidera realmente la vincita, ma necessiterebbe della sconfitta che assume a questo punto un carattere autopunitivo.
Forse il problema è un altro: il gioco (la dipendenza) esprime l’impossibilità della mente di superare lo scacco subito attraverso il trauma e la necessità di ripercorrerlo pressoché all’infinito nel vano tentativo di superarlo.
La grande domanda di fronte al Cristo di Holbein è proprio lì: vivere nella consapevolezza di un interrogativo aperto sulla tragicità dell’esistere.
Rendere consapevole a se stesso questo interrogativo permise, probabilmente, a Dostoëvskij di superare la dipendenza dal gioco, ma non era ancora una risposta del tutto soddisfacente.
La scrittura era una terribile responsabilità, ma anche una necessità incombente che rendeva tollerabile tornare con la mente alle sconvolgenti esperienze trascorse e rielaborarle.
Quello che possiamo assumere attraverso i suoi romanzi è l’importanza di aver la forza della propria miseria o umiliazione, la lealtà di affrontare il vuoto.
Non deflettendo mai, Dostoevskij approderà alla grande risposta pacificante e illuminante dei Fratelli Karamazov, non c’è che un solo mezzo per salvarsi: rendersi responsabili di tutti i peccati umani.
Risultato possibile, come già aveva intuito Agostino, perché lo sguardo di Dio sulla Creazione, sull’uomo, è un sofferto, amorevole e luminoso cammino che avviene per mutazione non per annientamento[17].
NOTE
[1] Fëdor Dostoevskij, Lettere sulla creatività, Feltrinelli, Milano 2011, pp. 27-32.
[2] Ripresenterà la scena nell’Idiota: Gli restavano da vivere cinque minuti, non di più. Egli diceva che quei cinque minuti gli erano parsi interminabili, una ricchezza enorme. Gli pareva che in quei cinque minuti avrebbe vissuto tante vite […] Moriva a ventisette anni, pieno di salute e di forza, e ricordava che, dicendo addio ai suoi compagni, aveva fatto a uno di essi una domanda abbastanza banale, e si era anche molto interessato alla risposta […] ma egli diceva che in quel momento nulla era stato più penoso del pensiero incessante: “se potessi non morire, se potessi far tornare indietro la vita, quale infinità! E tutto questo sarebbe mio! Io allora trasformerei ogni minuto in un secolo intero, non perderei nulla, terrei conto di ogni minuto, non ne sprecherei nessuno!”. Diceva che alla fine quel pensiero s’era tramutato in una tal rabbia, che ormai desiderava che lo fucilassero al più presto. Idem., L’Idiota, ebook, pag. 59. https://www.writingshome.com/
[3] Dostoevskij ebbe parole severe per questo comportamento disumano. Uccidere per un’uccisione è una punizione incomparabilmente più grande dello stesso delitto. L’omicidio su sentenza è incomparabilmente più orribile dell’omicidio del delinquente. Chi viene ucciso dai briganti viene sgozzato di notte, in un bosco, o da qualche altra parte, e fino all’ultimo momento spera di salvarsi. Ci sono esempi di persone che avevano già la gola tagliata e speravano ancora o correvano, o pregavano. Qui invece quest’ultima speranza, con la quale morire è dieci volte più leggero, la tolgono con certezza. Qui esiste una sentenza, e nel fatto che con certezza non sfuggirai sta tutto l’orribile tormento, e un tormento più forte al mondo non esiste. Voi potete mettere un soldato davanti a un cannone in combattimento, e sparargli addosso, e lui continuerà a sparare, ma leggete a questo stesso soldato una sentenza che lo condanna con certezza, e lui impazzirà o si metterà a piangere. Chi ha detto che la natura umana è capace di sopportare questo senza impazzire? Perché un simile oltraggio mostruoso, non necessario, inutile? Forse esiste anche una persona a cui hanno letto la sentenza, è stato dato il tempo di tormentarsi, e poi le hanno detto: “Vattene, sei graziato”. Ecco, forse quell’uomo potrebbe raccontarlo. Anche Cristo ha parlato di questo tormento, di questo orrore. No, non si può agire così con un uomo! Ivi, pag. 22.
[4] F Dostoevskij, La febbre del gioco, Milano, Marcos y Marcos, 2021, pag. 18.
[5] F. Dostoevskij, Il giocatore, ebook https://www.writingshome.com/
[6] F. Dostoëvskij, Memorie del sottosuolo, Torino, Einaudi 2005, pag 3
[7] Altra traduzione possibile: rappresentare un uomo assolutamente bello, cfr.F. Dostoëvskij, lettere sulla creatività, cit. pag. 82.
[8] F. Dostoëvskij, Epistolario (a cura di E. Lo Gatto), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1950, vol. I pag. 317
[9] Epistolario, vol. II pp. 43-44.
[10] F. Dostoevskij, lettere sulla creatività, cit. pagg. 81-86.
[11] Ho perduto tutto al gioco, tutti e 30 i talleri che mi hai mandato (…). Io, vedendo che occorreva aspettare fino alle sei e mezza per partire di qui, mi diressi alla stazione. Adesso, Anja, mi creda tu o non mi creda, ti giuro che non avevo intenzione digiocare (…). Io non volevo giocare per due ragioni: 1. La tua lettera mi aveva colpito troppo (…); 2. Questa notte ho visto in sogno mio padre, ma in un aspetto così terribile, quale due volte sole m’era apparso nella vita, profetandomi una terribile sventura e tutte e due le volte s’era verificata (…). Ma arrivato alla stazione mi sono messo vicino al tavolo da gioco e nel pensiero ho incominciato a indovinare e dieci volte di seguito, non ci crederai, ho indovinato. Ne sono stato così sbalordito che ho incominciato a giocare e in 5 minuti ho vinto 18 talleri. E qui, Anja, non mi ricordo più (…). Ricordati che non sono un infame, ma solo un appassionato giocatore. (Ma ricordati anche che adesso questa fantasia è finita per sempre. Anche prima ti ho scritto che è finita per sempre, ma mai ho provato quel sentimento con cui adesso ti scrivo). Alle nove e mezzo avevo perduto tutto e uscii come pazzo (…). Anja, salvami per l’ultima volta, mandami 30 talleri (…). Non giocherò. Credimi. Credimi per l’ultima volta e non te ne pentirai (…). Non pensare che io sia pazzo. Si è verificato in me qualcosa di grande; è sparita l’ignobile fantasia che mi ha tormentato per quasi dieci anni. per quasi dieci anni (o per meglio dire, da quando morì mio fratello e io mi sentii sotto il peso dei debiti); sognavo di vincere, lo sognavo seriamente, con passione. Ora tutto è finito! E’stata veramente l’ultima volta! Mi credi, Anja, che adesso ho le mani sciolte? Io ero legato al gioco e adesso penserò a quel che debbo fare e non fantasticherò per notti intere intorno al gioco, come è stato finora (Epistolario, vol. II, pp. 297-301
[12] S. Freud: Dostoëvskij e il parricidio (1927) in: Opere, vol. 10, Torino, Boringhieri, 1976, pp. 521-541.
[13] Verrà rielaborato anche nell’Idiota, ebook, pagg. 217ss // 399ss.
[14] Ib., pag. 218
[15] Ib., pag 400
[16] L’interpretazione di Freud, cfr. nota 12.
[17] Condotto a termine il giudizio, cesseranno questo cielo e questa terra, poiché avranno inizio un cielo nuovo e una terra nuova. Infatti questo mondo cesserà con una mutamento, non con una totale distruzione. Per questo l’Apostolo dice: Passa la conformazione di questo mondo, vorrei che voi foste senza preoccupazione Passa dunque la conformazione, non l’essenza. (Augustinus, De Civitate Dei, XX, 14)