di Roberto Pecchioli
.
Per leggere la prima parte, Minima amoralia. Politeismo dei valori, fine dell’etica, clicca qui
.
 Alasdair Mc Intyre, scozzese di stirpe gaelica, impropriamente considerato pensatore comunitarista, è al contrario un grande filosofo morale, capace di riportare Aristotele e Tommaso d’Aquino al centro della riflessione postmoderna. La sua opera principale, che uscì con notevole clamore nel 1981, Dopo la virtù, è il tentativo di rifondare l’etica attraverso i principi di Bene e di Virtù. Significativo è il punto da cui muove, paragonando il nostro tempo, in particolare la condizione etica e morale, ad un Day after successivo ad una tremendo evento distruttivo.
Alasdair Mc Intyre, scozzese di stirpe gaelica, impropriamente considerato pensatore comunitarista, è al contrario un grande filosofo morale, capace di riportare Aristotele e Tommaso d’Aquino al centro della riflessione postmoderna. La sua opera principale, che uscì con notevole clamore nel 1981, Dopo la virtù, è il tentativo di rifondare l’etica attraverso i principi di Bene e di Virtù. Significativo è il punto da cui muove, paragonando il nostro tempo, in particolare la condizione etica e morale, ad un Day after successivo ad una tremendo evento distruttivo.
Vale la pena citare integralmente il brano iniziale di Dopo la virtù: “Immaginate che le scienze naturali debbano subire le conseguenze di una catastrofe. L’opinione pubblica incolpa gli scienziati di una serie di disastri ambientali. Accadono sommosse su vasta scala. Laboratori vengono incendiati, fisici linciati, libri e strumenti distrutti. Infine un movimento politico a favore dell’Ignoranza prende il potere, e riesce ad abolire l’insegnamento scientifico nelle scuole e nelle università, imprigionando e giustiziando gli scienziati superstiti. Più tardi ancora c’è una reazione contro questo movimento distruttivo, e persone illuminate cercano di riportare in vita la scienza, pur avendo in larga misura dimenticato che cosa fosse. Non possiedono altro che frammenti: una conoscenza di esperimenti separata da qualsiasi conoscenza del contesto teoretico che conferiva loro un significato; parti di teorie senza legami né con gli altri pezzetti di teoria che essi possiedono, né con gli esperimenti; strumenti il cui uso è stato dimenticato; mezzi capitoli di libri, singole pagine di articoli, non sempre del tutto leggibili perché stracciate e bruciacchiate.”
Tale è il punto in cui ci troviamo, rispetto all’etica, alla sua polverizzazione. Scarnificata, desertificata, ne sopravvivono frammenti. Solo una nuova idea di virtù, ovvero di eccellenza personale e comunitaria può rianimarla. Mc Intyre conclude con un’amara constatazione, della quale dobbiamo fare tesoro in positivo: invocando la costruzione di forme locali di comunità al cui interno la civiltà e la vita morale ed intellettuale possano essere conservate nei secoli oscuri che incombono, egli ci avverte che i barbari non aspettano al di là delle frontiere. La parte più grande delle presenti difficoltà è la nostra inconsapevolezza di questo fatto. “Stiamo aspettando”, conclude. “Non Godot, ma un altro San Benedetto, senza dubbio molto diverso.” E’ assai probabile che una simile speranza abbia mosso Joseph Ratzinger, il papa che ha voluto chiamarsi Benedetto e tentare la carta disperata e sinora perdente di reagire al nichilismo contemporaneo. Benedetto da Norcia è stato il rifondatore della rinascita culturale europea medievale, e la sua regola era sintetizzata nel motto “Ora et labora”, prega e lavora, impegnati e studia, poiché il terzo imperativo benedettino era “lege”, leggi.
Nell’oscura stagione del tramonto di Roma, fu il segno di un nuovo inizio, lo stesso che Mc Intyre affida ad una espressione della sua nativa lingua gaelica “Gus am bris an la”, scolpita in molte lapidi dei cimiteri irlandesi “In attesa che sorga il sole, e si diradino le ombre della notte”. Tuttavia, non si può attendere inermi, ma operare con perseveranza per rifondare su basi rinnovate un’etica dell’eccellenza, della costruzione plastica, incessante di se stessi che realizza il miglioramento del mondo. Nietzsche, sulle tracce del poeta greco Pindaro, suggeriva di diventare ciò che si è. Vi è una doppia lettura: da una parte il nichilismo passivo, il lasciarsi vivere, trascinati da pulsioni ed istinti (Dioniso). Dall’altra, il paziente, severo lavoro su stessi che permette di trarre il meglio dalla propria vita, scoprendo e costruendo un ordine, una scala di principi e valori in cui, inevitabilmente, vi è un inferiore ed un superiore, un bene ed un male. Apollo, il giudizio di merito, l’equilibrio, l’etica della responsabilità, grande assente di quest’epoca devota alle pulsioni incontrollate, sottomessa all’interesse, all’attimo, al culto superstizioso del nuovo, dell’eccentrico, del bizzarro e, parallelamente, dell’Uguale, del prodotto di scala a taglia unica.
Uno scrittore ed aforista calabrese fuori dagli schemi, Giovanni Soriano, in Malomondo, pronuncia una sentenza di grande efficacia: “Voler essere come tutti gli altri e temere di essere sé stessi è il primo passo verso la follia”. Una follia perseguita, organizzata, sapientemente orientata dalle mille agenzie dei “minima amoralia” contemporanei, cui non riescono né, probabilmente vogliono, rispondere le religioni, la filosofia, le ideologie politiche, screditate, degradate a “narrazioni” nel lessico di Jean François Lyotard.
Pure, nessuna etica può escludere la virtù. Nella lunghissima stagione in cui il cristianesimo rappresentò il massimo riferimento morale degli europei, la saggezza della dottrina individuò due tipi di virtù, le tre teologali, fede, speranza e carità, ma saldamente connesse alle prime altre quattro, dette cardinali, tratte da Platone e dalla saggezza dei classici, pilastri, cardini della vita interiore e del comportamento quotidiano, prudenza, giustizia, fortezza, temperanza. Tutt’altro che principi deboli, o morale da schiavi, come equivocò Nietzsche, ma criteri universali per un’etica “verticale”. Osserviamo che tutte insieme, le virtù cardinali convergono nel principio di onore personale.
L’onore, altro grande assente di questo tempo meschino, sostituito dall’immagine, ciò che desideriamo appaia di noi, distante e distinto da ciò che siamo davvero. Il senso dell’onore è virtù etica in sommo grado, poiché rinvia all’universo dei doveri, degli obblighi autoimposti (noblesse oblige, la nobiltà obbliga!), a ciò che viene compiuto ed adempiuto in quanto conforme alla regola che ci si è data, lontano dall’interesse, anzi spesso in contraddizione con esso. L’etica dell’onore ha anche una importante caratteristica: è bifronte, ovvero corrisponde alla tensione esigente della persona a migliorare, conformando se stesso a principi elevati, ma insieme richiede un diritto rivendicato senza sconti, l’essere considerato e rispettato per ciò che si è e per gli atti e comportamenti concreti.
Chi pratica il senso dell’onore guarda verso l’alto, mira al massimo, a quelle linee di vetta che lo qualificano come persona etica, dunque onorata. Una bella definizione la diede il Manzoni riguardo al cardinale Federigo Borromeo, la cui vita fu “il paragone delle parole”. Potremmo rammentare anche l’onore come conformità a ciò che è permanente, stabile, quelle “idee senza parole” che Oswald Spengler individua in ciò che abbiamo ricevuto dai nostri padri, “l’unica cosa che garantisce la solidità dell’avvenire”. Dal punto di vista della morale utilitarista, l’onore non ha senso: esso, infatti, “oggettivamente, non serve a niente”, spiega De Benoist. Qui, essenziale è la scelta del verbo, servire.
Il verbo del sensale, di chi vive nel calcolo di costi e benefici, dello stesso Franklin citato nella prima parte. Tuttavia, a ben guardare, gli atti ed i gesti davvero importanti della nostra vita “non servono”, non rispondono ad uno scopo pratico o a un tornaconto preciso, e per questo assumono significato etico. Nelle comunità tradizionali, ciò che aveva un grande valore doveva essere donato. Io ho quel che ho donato è una nota espressione di Gabriele D’Annunzio che, depurata dalla magniloquenza del personaggio, esprime la cifra interiore dell’uomo d’onore. La mentalità utilitarista, unita ad un sociobiologismo d’accatto, è riuscita a svalutare anche questo, sostenendo che l’obbligo tradizionale del dono, dell’accettazione e del contro-dono di valore almeno analogo o superiore non sia che una forma sublimata di calcolo finalizzata all’aspettativa di un interesse futuro. Non si salva nulla, fuori dall’etica della virtù.
Nondimeno, prendiamoli in parola: un’etica dei doveri, delle intenzioni e dei comportamenti, per ragionare come piace a loro, “funziona”, serve. Si vive meglio circondati da un certo ordine esteriore, frutto di un centro interiore, si affrontano meglio le insidie della vita se inseriti in una comunità in cui ci si rispecchia. E’ un fatto che le morali astratte, universali, sono il vano tentativo di addomesticare l’ostilità reciproca di una miriade di gruppi reciprocamente estranei. Solo il ricorso obbligato alla legge scritta, alla coercizione che ne deriva, permette un minimo di convivenza. E’ esperienza comune, tuttavia, che i principi vissuti come naturali, introiettati dal sentire comune, siano gli unici che resistono nel tempo ed alla continua decostruzione di un secolo scisso e disordinato.
Le condizioni di un’esperienza etica decente dipendono essenzialmente da forme di vita condivisa e dalle pratiche di una comunità all’interno della quale iscriviamo naturalmente i valori in base ai quali compiamo le nostre scelte. Per dirla con Jung, l’etica è parte del Sé, lo sguardo con cui osserviamo noi stessi, a sua volta influenzato dall’inconscio collettivo. L’etica, diciamolo, è la rivincita del Superio che, praticando prudenza e temperanza, ed esercitando la fortezza sulla parte infera della personalità di ciascuno, ricaccia l’Es nel buio da cui Freud lo ha tratto con le drammatiche conseguenze che vediamo. Certo, bisogna ricominciare ad esprimere giudizi di merito, pronunciarsi su una scala di valori e fare ogni sforzo per praticarli. E’ più difficile che lasciarsi vivere, aderire senza riflettere a mode e umori del momento, accettare l’equivalenza, l’indifferente, il più semplice ed il meno impegnativo.
C’è poi il problema dell’Altro da sé, che il pensiero corrente iscrive in un egalitarismo imbarazzante: l’Altro viene posto infatti come identico, Stesso. I doveri nei suoi confronti, in quest’ottica, contrastano con la sua alterità, poiché egli non differisce da noi. E’ uno spazio astratto, puramente formale, privo di segni distintivi, come mostrò Hanna Arendt. Ma la società utilitarista, alla fine, ignora l’Altro in quanto tale, impegnata com’è a giustificare i mezzi con il fine, che è poi il cinismo, la performance, il successo materiale che conferisce lo status sociale e permette di soddisfare consumi compulsivi scambiati per scampoli di felicità. La precisa condizione del tossicodipendente, felice solo durante gli effetti della sostanza che assume, e subito dopo svuotato, infelice, disgustato da se stesso. E’ probabilmente questo disgusto che manca all’uomo medio dalla morale incerta, utilitarista e aderente allo spirito del tempo. Gli ultimi Uomini, lo intuì Nietzsche, sono soddisfatti come l’animale dopo il pasto.
Per gli antichi, etica era innanzitutto essere in accordo con il cosmo, la cui eccellenza e perfezione erano modello e ispirazione. L’uomo moderno ha rovesciato il tavolo, è lui stesso a giudicare l’ordine naturale per rifondarlo, sottoporlo all’esame della sua morale angusta in cui si arroga il diritto di stabilire ciò che è giusto. Revocabilmente, tuttavia, poiché tutto passa e scorre, ed anche il giudizio inclina secondo circostanza. E’ probabilmente questa la croce contemporanea, il cambiamento continuo, la mutevolezza compulsiva, il mutamento del punto di vista. Hans Sedlmayr, muovendo dalla crisi estetica dell’arte contemporanea, la chiamò perdita del centro. La morte di Dio ha fatto il resto.
Ci soccorre uno sguardo ad oriente, il luogo dove tutto nasce. Perduta la Via (l’armonia generale del cosmo), resta la Virtù. Perduta la Virtù, resta l’Etica; perduta l’Etica, resta la Morale. Parola di Lao Tze, contemporaneo dei grandi greci. L’occidente, più che mai terra del tramonto, ha smesso di evocare la stoica tranquillità dell’anima. Può forse ripartire da un concetto caro a Martin Heidegger, quello della serenità del pensiero meditativo opposto all’inautenticità della vita quotidiana, “l’anima stabile di fronte alle cose”, base necessaria di un “radicamento futuro”.
C’è infine la nozione di stile, che implica una “messa in forma” dei comportamenti e delle attitudini, sino ad avvicinare etica ed estetica, lati di una medesima armonia che, in Grecia, unificava il buono ed il bello nella virtù. E’ importante compiere atti etici, ma ha un senso anche il come vengono compiuti, ed è questo lo stile, che impone di riconoscere il valore altrui, saper ammirare anche l’onestà, il coraggio e le qualità anche nei sostenitori di valori avversi e di cause errate. Ciò è divenuto impensabile per i portatori di visioni astratte basate sull’adesione a regole morali, che antepongono il Giusto o l’Uguale al bene ed alla virtù.
Contemporaneamente, questa attitudine insieme debole ed intollerante, frutto del weberiano politeismo dei valori, si confronta con esito infausto con “l’eterogeneizzazione dei valori sociali, il relativismo ideologico, la diversificazione dei modi di vivere” (M. Maffesoli). Si finisce in un calderone neo tribale, il cui unico lato positivo è forse l’espressione di un irrisolto, ma irriducibile bisogno etico. Jean Baudrillard lo chiamò “stadio frattale del valore”, un epidemia di idee contrastanti e confuse, che nascono, si sviluppano e disperdono aleatoriamente. D’altronde, non vi può essere alcuna seria istanza morale in una società in cui il solo modo di essere accettato è l’avere. Realizzarsi materialmente, avere successo, qualunque cosa significhi, per possedere i mezzi per consumare di più: questo ci insegnano h.24 televisione e pubblicità attraverso la forma della società dello spettacolo.
Alain De Benoist cita uno slogan del Lotto francese, che riassume perfettamente la direzione morale corrente: “E’ facile, economico e si può guadagnare molto “. La virtù non la pensa allo stesso modo, a cominciare dal suo orrore per ciò che è – o sembra- facile. Nessun risultato, nessuna conoscenza o principio può essere conseguito e mantenuto senza costanza e accettazione delle difficoltà. Il padovano Ruzante, anima popolana del Cinquecento, scrisse un verso semplice quanto efficace, “per ogni gaudenza, ci vuole sofferenza”. Tale è il cammino della virtù, ed il principio dell’etica: faticosa conquista dell’eccellenza personale, o almeno tenace tensione verso di essa, la marcia verso la Via, la volontà di esplorare la più dimenticata delle dimensioni, quella della profondità, opposta al mito moderno dell’estensione.
La virtù è tridimensionale, le transitorie, contraddittorie morali del nostro tempo conoscono solo l’estensione. Ignorano la profondità, disprezzano l’altezza, esaltano la superficie: minima amoralia per un gregge di turisti della vita. Di corsa da una parte all’altra, una fotografia, il selfie da postare su Facebook (io sono stato qui, il più banale certificato di esistenza in vita!) e via, verso altre cose, semplici oggetti da guardare senza vedere. Una buona volta, ascoltiamo il più europeo dei sudamericani, Nicolàs Gòmez Dàvila: le cattedrali non sono state fatte per l’ente del turismo.
(2. – fine)

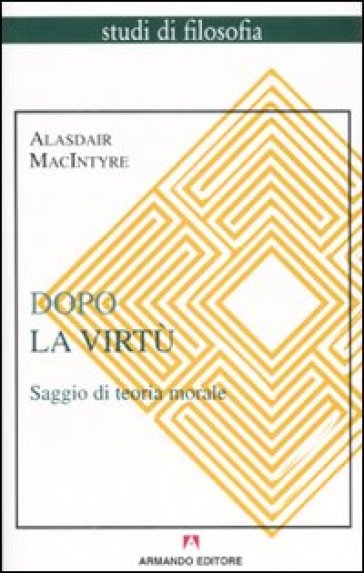




2 commenti su “Minima amoralia. Seconda parte: per un’etica della virtù – di Roberto Pecchioli”
Grazie per questo lungo dotto per molti versi illuminante articolo!
ciò che più si imprime nella mia mente leggendo questo articolo è l’epidemia di idee contrastanti e confuse, che nascono, si sviluppano e disperdono aleatoriamente. Complimenti per questo paragone efficace, lo si vede, ahimé, tanto negli adulti che navigano a Vista in un mare di pulsioni contraddittorie e cangianti, quanto nei giovani, che molto più spesso di quanto non si creda, Dagli adulti si aspetterebbero “istintivamente” un esempio migliore, molto migliore..