Stemma del Regno delle Due Sicilie
.
MEMORIAE TRADERE. Rubrica del sabato, a cura di Pucci Cipriani
.
Premessa
Ci avviamo a gran passi al Convegno della Tradizione Cattolica presso la “Fedelissima” Civitella del Tronto che si terrà la seconda settimana del mese di marzo del 2016 nei giorni venerdì 11, sabato 12 e domenica 13. Nell’attesa dell’evento più importante della Tradizione, vista la storia della “Fedelissima” Civitella, che fu l’ultimo baluardo del glorioso Regno del Sud (clicca qui per ascoltare la storia dell’eroica Resistenza di Civitella del Tronto), ho pensato di dedicare alcuni numeri di questa rubrica all’invasione del Regno del Sud e degli altri Stati preunitari, fino alla gloriosa difesa della Civiltà cattolica a Porta Pia contro la criminale invasione rivoluzionaria e massonica . Da tanti anni (dal lontano 1969) ci riuniamo, ogni anno, presso quella Fortezza abruzzese. Ricordo allora che, di fronte alla incombente minaccia del Comunismo e a quella, ancor più subdola, della “contestazione” lurida del Sessantotto che partì dai Campus americani, facemmo, sull’esempio dei fulgidi eroi antirisorgimentali, la nostra scelta di uomini di onore: rimanere fedeli al fatale trinomio : Dio – Patria -Re.
Ora vediamo la Santa Chiesa di Dio, come già aveva predetto San Giovanni Bosco, in mezzo a un mare procelloso, mentre si sta sradicando dal cuore dei giovani il concetto stesso di Patria e di Monarchia.
La nostra non è non sarà mai la “patria tricolorata” fatta con la “squadra e compasso” a tavolino dagli Alti Iniziati della Loggia d’Inghilterra e dai “fratelli d’Italia” perché noi, come il Vandeano Monsieur Charette abbiamo un concetto di Patria diverso da quello dei giacobini:
“La nostra Patria per noi sono i nostri villaggi, i nostri altari, le nostre tombe. Tutto ciò che i nostri padri hanno amato prima di noi. La nostra patria è la nostra Fede, il nostro Re. Ma la loro patria che cos’è per loro? Voi lo capite? Loro l’hanno in testa, noi la sentiamo sotto i nostri piedi”
Nulla fu risparmiato, in Vandea come nelle Terre del Sud (e l’Abruzzo fu la nostra Vandea), anche gli atti più criminali e ignobili, come lo sterminio di intere popolazioni (come Pontelandolfo e Casalduni) , le rappresaglie al cui cospetto impallidiscono quelle di Marzabotto e di Sant’Anna a Stazzema. Ma la vittoria della Rivoluzione fu una vittoria, destinata, col tempo a svanire… quegli eroi che, con il sangue, sigillarono quel loro sacrificio vivranno in eterno nei nostri cuori e nella gloria dei Cieli.
Pucci Cipriani
- – – – – – – –
Guardate il film di Pasquale Squitieri “Li chiamarono Briganti” (CLICCA QUI). Non è un film ideologico (Squitieri si può definire un “anarchico”) e quindi parla male di tutti : degli invasori sabaudi, dei Borboni, condannati per la loro inerzia e dei preti…e, forse, idealizza figure di “Briganti” che nulla hanno a che vedere con il “Lealismo” alla José Borjes. Comunque il film di Pasquale Squitieri – che fece andare su tutte le furie il partitume massonico italiano e il Potere (quel “sottile filo rosso” che dal 1800, passando dai primi Governi post-risorgimentali, all’Infame Guerra del 1915 – 1918 , anche attraverso il Fascismo e la Resistenza, è giunto fino alla tragica cultura del nichilismo e dell’ateismo contemporanei) – ha il merito grandissimo di aver presentato alcune sfaccettature della Guerra Civile Italiana. Naturalmente la pellicola fu tolta subito dalla circolazione (sembrava fosse reato financo il parlarne)… In Italia è proibito non solo parlar male del così detto risorgimento, ma perfino il parlarne. Dunque godetevi ora questo film che la censura “rossa” e “tricolorata” pensavano di non farci vedere.
e cliccate qui per la “L’inno dei briganti“
.
L’INSURREZIONE ABRUZZESE
di Domenico Rosa
.
 All’indomani dell’unificazione, contadini e braccianti meridionali si ribellarono alla politica di pesante tassazione imposta dai nuovi governanti piemontesi. Esplose nel Mezzogiorno una ribellione violenta e sanguinaria per contrastare l’annessione al nuovo Regno d’Italia, definita, per opportunismo politico, brigantaggio.
All’indomani dell’unificazione, contadini e braccianti meridionali si ribellarono alla politica di pesante tassazione imposta dai nuovi governanti piemontesi. Esplose nel Mezzogiorno una ribellione violenta e sanguinaria per contrastare l’annessione al nuovo Regno d’Italia, definita, per opportunismo politico, brigantaggio.
Col termine brigante si volle marchiare d’infamia chi combatté sotto la propria bandiera nazionale. A dirlo non è un nostalgico neoborbonico ma il deputato Giuseppe Ferrari nel suo intervento al Parlamento di Torino nel novembre del 1862[1]. Non riconoscere a chi si trova sul fronte opposto alcuna dignità politica, attingere a quel repertorio di parole che definisca l’altro ora “barbaro”, ora ‘brigante’ è il metodo più semplice e antico di demonizzare l’avversario e insieme legittimare se stessi. “Nel Meridione si verificò in anticipo – scrive Arrigo Petacco – quanto accadrà dopo l’armistizio del 8 settembre 1943, quando i soldati italiani, abbandonati dai loro comandi, si rifugiarono sulle montagne per accendere i primi fuochi di resistenza. Non a caso, anche i tedeschi li chiamarono briganti o banditi invece che patrioti. Lo stesso capitò ai soldati borbonici”[2].
L’analisi del deputato radicale Ferrari continua con estrema lucidità: “I padri di questi briganti hanno riportato per due volte i Borboni sul trono di Napoli […] È possibile, come il governo vuol far credere che 1.500 uomini comandati da due o tre vagabondi possano tener testa a un intero regno, sorretto da un esercito di 120.000 regolari? Perché questi 1.500 devono essere semidei, eroi!”[3].
Il Regno del Sud non era sicuramente l’Eldorado ma è innegabile l’attaccamento del popolo al sovrano. Se ne ha la prova quando nel corso del XIX secolo le terre meridionali furono invase ripetutamente e il popolo reagì sempre con un sussulto identitario, che alimentò un sentimento di diffidenza nei confronti dello straniero e che spinse alla difesa di una dinastia diventata indigena dopo oltre un secolo di dominazione[4]. Prima dei Piemontesi furono i Francesi a penetrare nell’Abruzzo nel 1798; le città, tranne una tenue resistenza del capoluogo, caddero senza colpo ferire, ma immediatamente le genuine popolazioni si organizzarono per la riconquista, spronate dal sovrano Ferdinando IV con un accorato appello: “Io accorrerò tra breve con un forte e numeroso esercito a difendervi, ma intanto armatevi e opponete all’inemico, nel caso avesse l’ardimento di passare i confini, la più valida e coraggiosa difesa. […] Pensate che voi avete a difendere il vostro paese, che la natura stessa difende colle vostre montagne, dove nessuna armata si è mai avanzata senza trovarvi il sepolcro. Coraggio bravi Sanniti, coraggio paesani miei, armatevi, correte sotto i miei stendardi, unitevi sotto i capi militari che sono nei luoghi più vicini a voi, accorrete con tutte le armi, invocate Iddio, combattete e state certi di vincere”[5]. In pochi mesi le truppe francesi, entrate a dicembre, abbandonarono l’Abruzzo tra la fine di aprile e i primi di maggio. Anima della vittoriosa insorgenza fu Giuseppe Pronio, coraggioso capo-massa di Introdacqua, che si distinse nella riconquista di Pescara e inflisse due ferite al generale Duschesme nella gola di Castel di Sangro.
Ma i francesi tornarono pochi anni dopo, sulla scia dei successi napoleonici. Il Bonaparte, celandosi abilmente dietro le grandi idealità della rivoluzione, diede luogo ad una sorta di familismo amorale, spartendo i regni conquistati tra i suoi congiunti: al fratello Giuseppe affidò il Regno di Napoli. Mentre l’avanzata francese procedeva inesorabile, le uniche fortezze resistenti rimasero, come avverrà più tardi con l’invasione piemontese, Gaeta e la piazza abruzzese di Civitella del Tronto. Quest’ultima comandata dal generale irlandese Wade che, senza esitazioni, rifiutò la resa intimata dai francesi e assieme al capo-massa Sciabolone, pianificò determinate azioni di guerriglia. Le truppe francesi, innervosite dall’accanita resistenza, bombardarono la città, ma senza ottenere risultati, cosicché la notte tra il 15 e il 16 aprile del 1806 si risolsero ad un attacco generale. L’attacco fu respinto dagli abitanti, ben sostenuti dalla guarnigione del forte. Soltanto con l’arrivo del generale Saint-Cyr le sorti volsero a favore dei francesi. Lo spietato generale ordinò di indirizzare tutti gli sforzi, non già contro il forte, scarsamente vulnerabile, ma contro la città, che costituiva il punto debole dell’intero sistema difensivo. Inoltre Saint-Cyr dispose che tutti gli abitanti colti con le armi in mano, dopo la presa della città, fossero immediatamente giustiziati.
 Dopo pochi decenni la storia si ripete, e questa volta a porre l’assedio saranno i Piemontesi. Civitella risponderà con il solito eroismo, tanto da guadagnarsi l’appellativo di Fedelissima. Siamo nel marzo del 1861 ormai anche la fortezza di Gaeta è caduta, e il sovrano Francesco II è costretto a riparare nello Stato Pontificio. I soldati e i popolani si battono valorosamente, la regina Maria Sofia ricama per loro una scritta d’oro sul vessillo borbonico: “Senza speranza”, il motto dell’onore. “Qui non c’è vanità, non c’è successo, non c’è ambizione: Ieri forse poteva sembrare più nobile, più alta la parte di là, ma oggi c’è con noi la sventura, e questa è la parte più bella. Perché sopra, noi ci possiamo scrivere: Senza speranza”[6]. La spietatezza con cui i Piemontesi agirono è testimoniata anche dalle parole del proclama del generale Pinelli: “Un branco di quella progenie di ladroni ancora si annida sui monti: correte a snidarlo e siate inesorabili come il destino. Contro nemici tali la pietà è un delitto; vili e genuflessi quando vi vedono in numero; proditoriamente vi assalgono alle spalle quando vi credono deboli; e massacrano i feriti. Indifferenti ad ogni principio, avidi solo di preda e di rapina, ora sono i prezzolati scherani del Vicario non di Cristo ma di Satana, pronti a vendere ad altri i loro pugnali, quando l’oro carpito alla stupida credulità dei loro fedeli non basterà più a saziare le loro voglie”[7]. Lo stesso sadico e spietato generale, una volta occupato il paese di Pizzoli in provincia de L’Aquila, fece fucilare il farmacista Alessandro Cicchitelli e sua moglie Marietta – che l’avevano accolto nella propria dimora – solo perché possedevano in un cassetto della casa il ritratto di Francesco II.
Dopo pochi decenni la storia si ripete, e questa volta a porre l’assedio saranno i Piemontesi. Civitella risponderà con il solito eroismo, tanto da guadagnarsi l’appellativo di Fedelissima. Siamo nel marzo del 1861 ormai anche la fortezza di Gaeta è caduta, e il sovrano Francesco II è costretto a riparare nello Stato Pontificio. I soldati e i popolani si battono valorosamente, la regina Maria Sofia ricama per loro una scritta d’oro sul vessillo borbonico: “Senza speranza”, il motto dell’onore. “Qui non c’è vanità, non c’è successo, non c’è ambizione: Ieri forse poteva sembrare più nobile, più alta la parte di là, ma oggi c’è con noi la sventura, e questa è la parte più bella. Perché sopra, noi ci possiamo scrivere: Senza speranza”[6]. La spietatezza con cui i Piemontesi agirono è testimoniata anche dalle parole del proclama del generale Pinelli: “Un branco di quella progenie di ladroni ancora si annida sui monti: correte a snidarlo e siate inesorabili come il destino. Contro nemici tali la pietà è un delitto; vili e genuflessi quando vi vedono in numero; proditoriamente vi assalgono alle spalle quando vi credono deboli; e massacrano i feriti. Indifferenti ad ogni principio, avidi solo di preda e di rapina, ora sono i prezzolati scherani del Vicario non di Cristo ma di Satana, pronti a vendere ad altri i loro pugnali, quando l’oro carpito alla stupida credulità dei loro fedeli non basterà più a saziare le loro voglie”[7]. Lo stesso sadico e spietato generale, una volta occupato il paese di Pizzoli in provincia de L’Aquila, fece fucilare il farmacista Alessandro Cicchitelli e sua moglie Marietta – che l’avevano accolto nella propria dimora – solo perché possedevano in un cassetto della casa il ritratto di Francesco II.
La piazzaforte di Civitella cadrà il 20 marzo, quando l’annessione a favore dello Stato Sabaudo era già stata votata tramite plebisciti-farsa, voluti da Vittorio Emanuele II. L’intento del monarca era quello di giustificare l’ingiusta aggressione come conseguenza della volontà popolare. Quando avvenne il plebiscito, il 21 ottobre 1860, il re si trovava proprio in Abruzzo, a Castel di Sangro. Alla sua presenza si svolse la votazione, in piazza dei Cannavini, poi ribattezzata, come altre innumerevoli piazze d’Italia, del Plebiscito. Al voto fu ammesso l’intero Esercito Meridionale, formato in maggioranza da piemontesi e da stranieri. I sudditi delle zone ancora presidiate dall’esercito napoletano non poterono votare, come non votarono gli stessi soldati regi che ne avevano diritto. La segretezza dell’urna fu regolarmente violata e non mancarono pressioni psicologiche oltre che naturalmente fisiche. I risultati pro-annessione nel meridione continentale furono schiaccianti: 1.034.258 “Sì” contro 10.327 “ No”. Ma le eccezioni in Abruzzo non mancarono, come a Quadri, nella parte meridionale, dove fu effettuato un vero e proprio sabotaggio. L’orgogliosa popolazione era largamente favorevole al “No”, così al momento di aprire l’urna furono rinvenuti 619 acini d’orzo in luogo dei bollettini[8]. A Caramanico, invece, il plebiscito non si svolse a causa dei tafferugli provocati da Camillo Colafella di Sant’Eufemia, che assieme ad altri facinorosi saccheggiarono e devastarono la città nei giorni 21-22-23 ottobre, con incursioni anche a Salle, Musellaro e Sant’Eufemia allo scopo di ripristinare il governo dei Borboni; successivamente uccisero per vendetta il capitano della guardia nazionale di Pacentro[9]. Nella splendida cornice di Civitaluparella, uno dei tanti “presepi” abruzzesi, sorprendentemente il “No” ebbe la meglio. Su 280 iscritti ne votarono soltanto 120, le cui preferenze risultarono 43 “Sì” e 77 “No”[10].
Già prima dei plebisciti, però, agli inizi del mese di settembre, in diversi punti del Regno emersero ed operarono attivamente bande di contadini accanto all’esercito napoletano, buona parte delle quali furono successivamente accorpate alle truppe regolari al servizio di Francesco II[11]. L’episodio più clamoroso si ebbe a Isernia, all’epoca negli Abruzzi, dove reparti borbonici e masse contadine sconfissero i corpi volontari ed una colonna garibaldina, spazzarono le strutture statali improvvisate dagli unitari, massacrarono le famiglie borghesi in fama di liberalismo, ripristinarono velocemente autorità e simboli dell’antico potere[12]. Alle ribellioni generalizzate il nuovo governo rispose con la più spietata repressione e nel 1863 emanò la famigerata legge Pica, dal nome del deputato abruzzese che la propose. Questa legge prevedeva la fucilazione immediata per chiunque venisse colto con le armi in pugno e l’istituzione di giunte provinciali di sicurezza, atte alla compilazione degli elenchi delle persone da inviare al domicilio coatto, tra i quali favoreggiatori e manutengoli. L’autorità passava dunque dai tribunali civili a quelli militari che sulla base di un mero pettegolezzo decretavano la pena capitale o addirittura la deportazione di anziani, donne e bambini. Ne è un esempio la fortezza di Fenestrelle, alle porte di Genova. La stampa dell’epoca commentava esterrefatta: “Se funesta e draconiana è la legge Pica, peggiore assai è l’applicazione che si fa della medesima nelle nostre province. Le disposizioni ministeriali date posteriormente hanno accresciuto il rigore di essa legge, e quindi agenti governativi, arrestano la gente in massa, in barba alla libertà e alla giustizia”[13]. La repressione di questa grande insorgenza risulterà nella realtà dei fatti come una vera e propria campagna di guerra, lunga e spietata, che solo per ragioni di opportunità politica sarà definita, sia dai governanti dell’epoca, sia dagli storici brigantaggio.
 Non c’è dubbio che un certo tipo di malcontento rurale fosse endemico in quelle regioni ma ora la popolazione oltre alla consueta esosità dei proprietari terrieri, doveva sopportare anche i nuovi balzelli imposti dal governo piemontese[14]. Come per esempio la “legge sulla Vendita delle Terre Demaniali”, che priverà i contadini degli usi civici, fino a quel momento usufruiti (pascolo, taglio della legna, raccolta di bacche), l’impopolarissima tassa sul macinato da versare direttamente ai mugnai e l’istituzione della leva obbligatoria, molto mal vista dalla popolazione, tanto che spesso i chiamati andavano ad ingrossare le file brigantesche. Ne è un caso quello di Geremia Rosa di Sante Marie (AQ), il quale denunciato per insolvenza agli obblighi militari dall’Antonini, signore a cui prestava servizio, si diede alla macchia, organizzando una banda. Per vendicarsi dell’accaduto sequestrò il suo padrone e si racconta che gli rivolse la seguente frase: “Eh patrò, vidi comme so più bono j che tu?! Tu me si fatto zompà dalla finestra e j te so fatto escì dalla porta”; successivamente lo condusse in mezzo alle montagne che da Tagliacozzo si estendono fino a Vallepietra. L’Antonini verrà liberato dietro la somma di un ingente riscatto e la banda di Geremia Rosa sarà sgominata nel 1871 dal carabiniere piemontese Chiaffredo Bergia[15].
Non c’è dubbio che un certo tipo di malcontento rurale fosse endemico in quelle regioni ma ora la popolazione oltre alla consueta esosità dei proprietari terrieri, doveva sopportare anche i nuovi balzelli imposti dal governo piemontese[14]. Come per esempio la “legge sulla Vendita delle Terre Demaniali”, che priverà i contadini degli usi civici, fino a quel momento usufruiti (pascolo, taglio della legna, raccolta di bacche), l’impopolarissima tassa sul macinato da versare direttamente ai mugnai e l’istituzione della leva obbligatoria, molto mal vista dalla popolazione, tanto che spesso i chiamati andavano ad ingrossare le file brigantesche. Ne è un caso quello di Geremia Rosa di Sante Marie (AQ), il quale denunciato per insolvenza agli obblighi militari dall’Antonini, signore a cui prestava servizio, si diede alla macchia, organizzando una banda. Per vendicarsi dell’accaduto sequestrò il suo padrone e si racconta che gli rivolse la seguente frase: “Eh patrò, vidi comme so più bono j che tu?! Tu me si fatto zompà dalla finestra e j te so fatto escì dalla porta”; successivamente lo condusse in mezzo alle montagne che da Tagliacozzo si estendono fino a Vallepietra. L’Antonini verrà liberato dietro la somma di un ingente riscatto e la banda di Geremia Rosa sarà sgominata nel 1871 dal carabiniere piemontese Chiaffredo Bergia[15].
Accanto ai loro uomini che si davano alla macchia ebbero un ruolo di rilievo anche le donne abruzzesi, sicure confidenti ed informatrici. Con scaltrezza si muovevano inosservate, riferendo preziose notizie sui movimenti dei carabinieri e portando munizioni sotto le loro ampie sottane. Queste, però, a differenza di quelle lucane, pugliesi o calabresi, non parteciparono agli scontri armati, ma rivestirono soltanto un ruolo logistico, come vivandiere, infermiere e porta ordini[16]. Ricordiamo una di loro detta “la mamma dei venti”, operante nei pressi del territorio di Borrello (CH). A questo nomignolo, come afferma lo studioso locale Eugenio Maranzano, si possono dare due interpretazioni: o “mamma dei vénti”, perché tanti erano i briganti a cui faceva da vivandiera, o “mamma dei vènti”, in quanto si spostava con incredibile velocità[17].
Ma ciò che è importante sottolineare è come nel brigantaggio, non ci fosse solo un fattore di malcontento sociale, ma anche una forte componente legittimista, intesa come rivendicazione identitaria e come ribellione contro il capovolgimento di un sistema di valori[18]. Infatti, i primi ad ingrossare e spesso a formare bande di briganti saranno proprio ex soldati ed ex sottoufficiali borbonici[19], al contrario dei loro comandanti che si integrarono alla perfezione nell’esercito piemontese, mantenendo lo stesso grado e soprattutto la stessa paga[20]. Cosicché le bande brigantesche assunsero una vera e propria fisionomia di reparti militari, organizzati a somiglianza di quelli del disciolto esercito borbonico. Particolarmente attive furono le bande in azione ai confini dello Stato pontificio, nel cui territorio trovarono sicuro appoggio e rifugio. A Palazzo Farnese, nella Roma ancora papale, fu istituito il centro operativo borbonico, dove assieme al sovrano Francesco II si perseguiva tenacemente il disegno di riconquista del perduto regno[21].
Tra i briganti abruzzesi più temuti ricordiamo Antonio La Vella, alias Scipione, ex soldato dell’esercito borbonico protagonista di numerose scorribande assieme ai fratelli Felice e Giuseppe Marinucci. La loro banda, detta dei Sulmontini, operò nella valle Peligna. A Pacentro, invece, fu molto attiva la banda capeggiata da Pasquale Mancini, detto Mercante che assieme a Luca Pastore di Caramanico si spingerà nei territori più impervi della Majella e con rapide incursioni e inneggiando ai Borboni, saccheggeranno e devasteranno Pretoro, Pennadiedimonte e Roccacaramanico. Dopo la cattura di Pastore avvenuta nell’ottobre del 1862 e la scomparsa di Mancini, i briganti della Majella, saranno capeggiati da Nicola Marino sul versante occidentale e da Salvatore Scenna e Domenico Di Sciascio sul versante orientale[22]. Degni di nota sono Domenico Valerio, alias Cagnotto, contadino di Casoli, che evaso dal locale carcere diventerà il “più famigerato brigante della provincia” e nell’aquilano Primiano Marcucci di Campo di Giove, Croce di Tola e Nunzio Tamburrini di Roccaraso[23]. Infine, ricordiamo Vincenzo Rosa di Quadri, accusato di “aver promosso la reazione” dal 1860 al 1866 e di aver fatto parte della banda del nipote del famoso brigante Chiavone[24]. Così si esprimeva l’allora sindaco del piccolo borgo in provincia di Chieti, Camillo D’Amico, in una nota informativa al Sottoprefetto di Lanciano: “Sul conto di Vincenzo Rosa di Quadri, le manifesto quanto appresso: Nella reazione avvenuta in questo Comune nel 1860, il Rosa vi ebbe molto parte, anzi ne fu il promotore, perché borbonico. Accorsa la truppa per sedarla, come in effetti fu sedata, il medesimo temendo di essere arrestato si allontanò dal paese, ricoverandosi a Roma, che in quel tempo era il rifugio dei reazionari”[25]. Nel giugno del 1862 partecipò all’attacco di Gamberale, dove, afferma il consigliere anziano Raffaele Bucci: “[Il Rosa] faceva parte della banda brigantesca comandata dal nipote di Chiavone quando nel 1862 assalì questo Comune e ne fu respinto”[26].
Dopo più di un decennio di latitanza soltanto nel maggio del 1872 Vincenzo Rosa sarà arrestato a Napoli e condotto nelle carceri circondariali di Lanciano.
La dura repressione seguita all’unificazione italiana è descritta perfettamente da Antonio Gramsci: “Lo Stato italiano è stato una dittatura feroce che ha messo a ferro e fuoco l’Italia meridionale e le isole, squartando, fucilando seppellendo vivi i contadini poveri che scrittori salariati tentarono di infamare col marchio di briganti”[27].
La tenacia e la fedeltà al proprio re consentirono la prosecuzione della battaglia pro borbonica. A emblema della resistenza che fu è rimasto nelle memoria collettiva un vecchio proverbio che si riferisce alla testardaggine degli abruzzesi: “La coccia n’cim o’ cipp, viva Francisc!” (Anche sul patibolo viva re Francesco).
.
NOTE
[1] Citato in P. K. O’Clery, La Rivoluzione Italiana, come fu fatta l’unità della nazione, Milano, Ares, 2000, pp. 508-510.
[2] A. Petacco, O Roma O Morte, Milano, Mondadori, 2010, pp. 10-11.
[3] In P. K. O’Clery, op. Cit. pp. 508-510.
[4] A. Scirocco, Il brigantaggio e l’Unità d’Italia, in Brigantaggio lealismo repressione nel Mezzogiorno 1860-1870, Napoli, Macchiaroli, 1984, p. 20.
[5] Citato in R. Canosa, Storia dell’Abruzzo in età borbonica, Ortona, Menabò, 2005, pp. 180-181.
[6] C. Alianello, L’Alfiere, Venosa, Osanna, 1943 p. 429.
[7] G. Maffei, M. de Leonardis, P. Cipriani, La fedelissima Civitella del Tronto. L’ultimo baluardo del Regno delle due Sicilie, Firenze Controrivoluzione, 2006, p 26.
[8] Archivio di Stato di Chieti, Risultati dei plebisciti del 1860, cfr. anche E. Maranzano, Borrello, tra i vicini paesi della Val di Sangro, Casoli, 1998, p. 260 e G. O. D’Amico Quadri un paese del medio Sangro, Sanbuceto, Edizione Quale dita 2006, p.76.
[9] Archivio di Stato di Chieti, Risultati dei plebisciti del 1860.
[10] Ibidem.
[11] Cfr. F. Molfese, Storia del brigantaggio dopo l’Unità, Milano, Feltrinelli, 1964, pp. 12-21.
[12] Cfr. A. Scirocco, Il brigantaggio e l’Unità d’Italia, in Brigantaggio lealismo nel mezzogiorno, 1860-1870, cit, p. 20.
[13] Citato in L. Torres, Il Brigantaggio nell’Abruzzo Peligno e nell’Alto Sangro, Alessandria, Majella, 2001, p. 124.
[14] Cfr. A. Petacco, O Roma O Morte, cit. p. 10.
[15] C. Zocchi, I Carabinieri nella lotta al brigantaggio post-unitario in Abruzzo, Presidenza del Consiglio della Regione Abruzzo, Teramo, 1998, p. 49.
[16] L. Torres, Il Brigantaggio nell’Abruzzo Peligno e nell’Alto Sangro, cit. p. 125.
[17] E. Maranzano, Borrello, tra i vicini paesi della Val di Sangro, p. 263.
[18] Cfr. S. Lupo, Il grande brigantaggio. Interpretazione e memoria di una guerra civile, in Storia d’Italia, Annali 18, Guerra e Pace, a cura di W. Barberis, Torino, Einaudi 2002, p. 468.
[19] Cfr. A. Scirocco, Il brigantaggio e l’Unità d’Italia, in Brigantaggio lealismo nel Mezzogiorno, 1860-1870, p.20.
[20] Cfr. A. Petacco, O Roma O Morte, cit. p.10.
[21] L. Torres, Il Brigantaggio nell’Abruzzo Peligno e nell’Alto Sangro, cit. p. 126.
[22] A cura di C. Viggiani, Brigantaggio Ottocentesco in Abruzzo, Archivio di Stato Chieti, pp. 27-28.
[23] Ibidem pp. 47-48.
[24] Archivio di Stato Sezione di Lanciano, Sottoprefettura, Busta 152/2-1.
[25] Ibidem
[26] Ibidem
[27] A. Gramsci, da Ordine Nuovo, 1920.

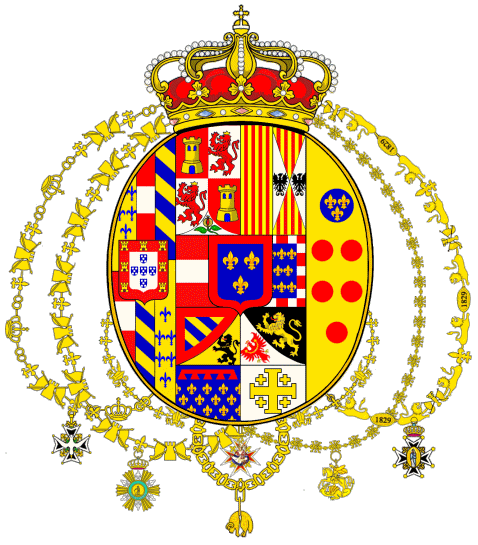





8 commenti su “Memoriae tradere. L’insurrezione abruzzese – di Domenico Rosa. Con una premessa di Pucci Cipriani”
l’8 settembre fu una vergogna nazionale. I soldati sbandati, si dettero alla macchia e organizzati dal pci, si trasformarono i veri e propri briganti irregolari che sparavano volentieri alla schiena contro i tedeschi, che fino al giorno prima erano stati nostri alleati. Non so se sia il caso di paragonarli ai rivoltosi filoborbonici in un contesto completamente diverso, dove vi fu un’invasione illeggittima da parte dei savoiardi, i cui eredi furono responsabili della vergogna dell’8 settembre.
Quasi INCREDIBILE….
…e a scuola ci hanno imbottito il cervello con l’epopea risorgimentale, con il vero brigante definito “l’eroe dei due mondi”, con “il grido di dolore che si leva…”e con la menata dei “mille”. Nulla sui campi di concentramento (Fenestrelle ed altri), nulla sui saccheggi, nulla sui massacri, nulla sul miliardo e 200 milioni in monete d’oro (non carta straccia come le banconote piemontesi) andate a rigenerare le casse dei savoia. E poi hanno continuato per altri 150 anni a depredarci e continuano ancora oggi rubando in ogni dove e settore (persino nel calcio) con provvidenze di stato di ogni genere ma scrupolosamente trattenendo i profitti fino ad andarsene per non pagare le tasse ma, ovviamente, continuando ad ingrassarsi a spese nostre. Da De Gasperi a Renzi tutte marionette nelle loro mani. Loro i veri regnanti, continuatori delle nefandezze della orribile schiatta dei savoia. Gli stessi che oggi inneggiano a bergoglio!
La conquista del Sud fu una vittoria della massonica Inghilterra, patrona e maitresse della massoneria italiana. Purtroppo la rivoluzione massonica perdura ancora e dopo aver guastato un popolo ne sta distruggendo la struttura famigliare, il vero scheletro di ogni nazione e di ogni popolo. Distrutta la famiglia non ci sarà più capacità di reazione. Quousque tandem, Padre Misericordioso, si protrarrà l’agonia di questo popolo un tempo a Te tanto caro?
il problema dei veri italiani non è smembrare l’Italia ma chiudere la fogna liberale/libertina, fomite dei mali che ci tormentano e avviliscono: una classe politica elefantiaca, sciocca, inetta, vanesia e vorace, l’influsso dell’infame setta massonica, la ferula europea, la cultura intossicata dal nichilismo francofortese, le leggi criminogene, che promuovono la rovina (la legge che istituisce il divorzio, la sanguinaria legge che legalizza l’aborto, ecc.) – oggi come ieri i liberali sono il cancro della nazione italiana – i liberali (lo rammentava De Tejada) non sono nostri fratelli, sono alieni, parassiti, amici e manutengoli degli strozzini tedeschi ed esecutori della rivoluzione sodomitica, promossa dagli iniziati ai misteri del sottosuolo
Purtroppo queste vicende sono ancor poco o niente note. Consiglio la lettura di testi utili come quelli di Massimo Viglione sulle insorgenze dal 1796 al 1815, libera chiesa in libero stato e ancora L’identità ferita facilmente ordinabili su Internet
La fortezza di Fenestrelle non è alle porte di Genova, ma in Bassa Val di Susa (prov. Torino).
Questa storia del “risorgimento” è un letale vulnus dell’Italia – già dannata sin dalla sua nascita…