di Lino Di Stefano
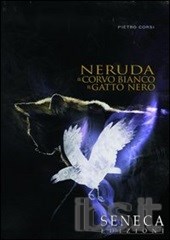 Pietro Corsi, l’autore del presente libro, – ‘Neruda, il Corvo bianco, il Gatto nero (Seneca Edizioni, Torino, 2013) – è stato un giramondo, e forse lo è ancora; giramondo inteso nel significato migliore del vocabolo nel senso che egli ha, effettivamente, percorso, per lavoro, buona parte della sua esistenza viaggiando: dal Canada, al Messico, dagli Stati Uniti a tanti altri Paesi del globo terracqueo, tant’è vero che, giustamente, un critico ha scritto che nell’universo dello scrittore molisano ci sono “navi e libri”.
Pietro Corsi, l’autore del presente libro, – ‘Neruda, il Corvo bianco, il Gatto nero (Seneca Edizioni, Torino, 2013) – è stato un giramondo, e forse lo è ancora; giramondo inteso nel significato migliore del vocabolo nel senso che egli ha, effettivamente, percorso, per lavoro, buona parte della sua esistenza viaggiando: dal Canada, al Messico, dagli Stati Uniti a tanti altri Paesi del globo terracqueo, tant’è vero che, giustamente, un critico ha scritto che nell’universo dello scrittore molisano ci sono “navi e libri”.
Essendo nato nel medesimo paese dell’Autore, avendo frequentato con quest’ultimo la Scuola Media, avendo vissuto le stesse esperienze della puerizia e dell’adolescenza ed essendo sempre rimasto in contatto con lui – anche se con scelte diverse – per più di mezzo secolo, non ho potuto non riconoscermi nelle vicissitudini narrate nel libro, pur restando estraneo ad ogni vicenda.
Pietro Corsi è tornato tante volte, dalle varie nazioni di residenza e di lavoro, nel suo paese natio, ma questa volta, nel lungo racconto, vi è approdato quando il luogo di nascita non era più lo stesso e quando, tutti i suoi congiunti erano, per la legge fatale del tempo, scomparsi, sicché dall’aeroporto ‘Leonardo da Vinci’ di Roma, proveniente dall’estero, in direzione, con il treno, nel Molise, l‘esperienza narrata è stata esaltante, triste e, nel contempo, irripetibile.
E’ capitato, più volte, anche a me – arrivato in aereo a Roma, con voli interni – proseguire, in treno, per il medesimo centro abitato e provare le identiche emozioni visto che, ormai, con la scomparsa dei genitori, e in qualità di figlio unico, ivi giacevano solo struggenti ricordi e il cimitero. Da Termini – con “animo perturbato e commosso”, per dirla col grande Vico – l’Autore giunge nel proprio paese; località irriconoscibile, dati l’esiguo numero degli abitanti, le offese del tempo, il cambiamento degli uomini e la loro scomparsa, per inderogabile legge naturale.
Lo scrittore rivive negli ambienti circostanti e nella solitudine della casa – dove vige l’algida forza del silenzio – le innumerevoli esperienze dell’infanzia e della gioventù; durante quest’ultima, egli decide di cercare lavoro all’estero, come tanti della sua e di altre generazioni ; siamo, più o meno a cavallo fra la prima e la seconda metà degli anni Cinquanta, allorquando, almeno, nel Centrosud, come per un diabolico incanto, i paesi si svuotano e la società si immiserisce in maniera paurosa.
Eppure il centro abitato in questione – dal pregnante nome latino – possiede tutti crismi per continuare la sua vita tranquilla e senza scossoni di sorta: la bella stazione ferroviaria, risalente al 1882, tre scuole – oltre alle elementari – come la Media, l’Avviamento professionale, l’Istituto industriale, la Pretura, l’Ufficio del Registro e delle Imposte, due farmacie, due cinema, il mulino, due pastifici, il Circolo cittadino, targato 1869, la Società operaia, più o meno coeva, e tanti altri uffici e negozi di vario genere. Non sufficienti, evidentemente, a salvarlo dalla crisi e dalla inesorabile decadenza.
L’Autore mette in evidenza tutto ciò, nel libro, e durante la breve permanenza, ‘in loco’, rivive sconsolato i momenti felici della giovinezza, prendendo atto che tanti abitanti del paese, per una fatalità ed un’esigenza imponderabili, decidono di operare un taglio netto col passato e di abbandonare – quasi sempre definitivamente – la propria patria dove, è giocoforza ammetterlo, non mancava, certo, la povertà, ma dove dominava, altresì, la solidarietà, l’amicizia, la fraternità e l’accontentarsi del poco.
Nel giro di pochi anni, questa realtà scompare e tutto svanisce nel totale abbandono; ma diamo la parola all’Autore: “In paese, dunque, non c’erano più giornalieri. Non c’erano braccianti, non c’erano contadini per i campi e le botteghe degli artigiani rimasero vuote, chiuse. (…) E dove una volta si udivano fabbri e ferrai che forgiavano il ferro per un’inferriata (…), ora non si udiva altro che il quieto vociare di qualche vecchia distratta che, senza saperlo, a voce alta, faceva, a se stessa, come una pazza, domande che non avrebbero mai trovato una risposta”. L’Autore, appena tornato – il padre e la madre riposano, da tempo, al camposanto – sente l’esigenza di recarsi in chiesa, richiamato dai rintocchi a morte delle campane della Chiesa madre, a due passi da casa sua.
Qui si sta svolgendo il funerale di un uomo, ma l’emigrante non sa chi sia; lo saprà più avanti. Ora, il libro in oggetto non si esaurisce soltanto nel giusto rimpianto del tempo passato, per il semplice motivo che esso, nella seconda parte, introduce il ricordo di un evento di cui ha chiaro ricordo anche chi scrive.
E si tratta di un fatto luttuoso che, a mo’ di giallo, rende sempre più interessante il presente racconto: in un bosco, la morte, accidentale, o voluta, di un uomo – chiamato ‘il cacciatore’, per antonomasia – appena tornato dal Canada dove resta diversi anni senza attraversare il guado; senza, cioè, chiamare la famiglia colà o ricongiungersi con essa in Italia. Alla fine, ‘il cacciatore’ rientra nel paese di origine dove trascorre una vita disordinata dedito soltanto alla caccia.
L’uomo, all’improvviso, scompare, per diversi giorni e non torna in famiglia; solo per merito di una sorta di ‘maga’ del luogo che racconta di aver sognato l’uomo, esanime, in un bosco – dove, tra l’altro, questi è solito recarsi – viene rinvenuto, appunto, morto. E’ lui il defunto di cui si sta svolgendo la cerimonia funebre nella Chiesa principale del paese. “Omicidio o suicidio?”, questa la domanda, senza risposta, dell’opinione pubblica e dell’Autore il quale, a questo, punto, intesse con il figlio dello scomparso una serrata discussione sul senso della vita e della morte.
Ad un certo punto, il giovane osserva: “ Ecco: tra vita e morte c’è un vuoto. Io penso al vuoto e mi chiedo: è quello, la vita? Un vuoto?”. “Sarà”, risponde l’interlocutore, ma una cosa è certa, continua: “la fine è segnata dall’inizio”. Quest’ultima frase, espressa nel dialetto del luogo, conferisce particolare rilevanza al concetto della caducità della ‘condizione umana’, direbbe André Malraux.
Lo scrittore, però è un credente, ed eccolo, che ad un certo punto, si reca al Convento di Sant’Onofrio – patrono del paese – a qualche chilometro di distanza, sia, egli scrive, “per lavarsi la coscienza” e sia, infine, “per cercare di scoprire, tra la severità di quelle mura centenarie, il segreto di una vita nuova al di là della morte”, ed operare, infine, un bilancio della propria laboriosa vita prima di riprendere la via dell’esilio.
Nella breve Prefazione, l’Autore dice, opportunamente, che “partendo da alcuni insidiosi pensieri contenuti nelle ‘memorias’ di Pablo Neruda e rimuginando sulle antiche leggende del mondo Haida della British Columbia (il corvo bianco) e sulle superstizioni dell’entroterra italiano (il gatto nero), il protagonista di questo insolito racconto ci trasporta, con trasparente sensibilità, nel mondo dell’emigrazione italiana del secondo dopoguerra”.




1 commento su “LA FORZA DELLE MEMORIE. RECENSIONE DI “NERUDA, IL CORVO BIANCO, IL GATTO NERO” DI PIERO CORSI, ED. SENECA – di Lino Di Stefano”
Leggo solo oggi, 19 febbraio 2016, la tua bella recensione. Sono seduto alla mia scrivania qui a Mazatlan, nel Messico, con un mare tranquillo, tutto azzurro, che si affaccia sul mondo. Un mondo, per me, vissuto ma sempre con l’istinto dell’emarginato che va e viene, parte e torna, senza mai effettivamente partire, senza mai effettivamente tornare. Ma so che esattamente fra due mesi, il 19 aprile di quest’anno, sono di nuovo a casa. A casaCalenda. Un abbraccio.
Pietro