CORSO DI ESCATOLOGIA
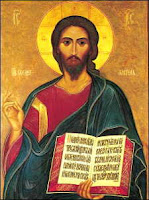
La beatitudine dopo la morte
di P. Giovanni Cavalcoli, OP
per leggere l’introduzione al corso: “Che cos’è l’escatologia”, CLICCA QUI
per leggere il primo capitolo: “La morte e l’immortalità dell’anima”, CLICCA QUI
per leggere il secondo capitolo: “Immortalità e Resurrezione”, CLICCA QUI
per leggere il terzo capitolo: “La Parusia di Cristo”, CLICCA QUI
Proseguendo il nostro piccolo corso di escatologia, giungiamo ad una dottrina che può lasciare increduli e che di fatto nella storia del pensiero umano è stata oggetto di netta e varia negazione, come per esempio da parte della tradizione materialistica. Ma nel contempo la dottrina dell’immortalità dell’anima e della possibilità di un’eterna beatitudine dopo la morte ha anch’essa al suo attivo una storia altrettanto e forse ancor più consistente e documentata, non solo nell’ebraismo e nel cristianesimo, ma anche in altre religioni vuoi tradizionali vuoi moderne, sia evolute che primitive, ad Occidente come ad Oriente. Si tratta della dottrina che sostiene la superiorità dello spirito sulla materia, nonché la perennità dello spirito e la contingenza della materia.
Accanto alla concezione materialistica c’è anche sin dall’antichità, ad Oriente come ad Occidente, una concezione monistico–panteistica, la quale sostiene che le anime non sono che scintille di un unico Fuoco eterno e divino, le quali, sprigionate da questo Fuoco, poi ricadono in esso per fondersi con esso. Quindi non c’è una vera distinzione tra l’anima (atman) e Dio (Brahman), ma l’anima non è che un “momento” o “modalità” dell’Assoluto, una manifestazione (“teofania”) divina, un farsi “finito” di Dio nello spazio–tempo. In questa visuale c’è una beatitudine eterna dopo la morte, ma essa consiste nella beatitudine dell’unico Fuoco divino nel quale le anime vanno “beatamente” a dissolversi. Sostenitori di questa dottrina in Occidente sono Spinoza ed Hegel.
Oggi inoltre ci sono teologi considerati “cattolici”, come Rahner, non distante da Hegel, il quale sostiene che non ha neppur senso parlare di una sopravvivenza o di una permanenza dell’anima “dopo” la morte, col pretesto che, essendo l’anima spirituale ed essendo lo spirito eterno ed al di sopra del tempo, non ha senso parlare di un’anima separata dal corpo che continua ad esistere “dopo” la morte, poiché il prima e il dopo riguardano il tempo, mentre lo spirito è al di sopra del tempo. Curiosa difesa dello spiritualismo che finisce per andare a braccetto con la negazione materialistica dell’immortalità dell’anima. Sia il materialismo che il panteismo, con motivi opposti, negano la vera dignità dell’anima e della persona umana.
Così per Rahner, come abbiamo già visto circa la questione della resurrezione del corpo, il corpo non risorge dopo la morte, ma nella morte, con la quale peraltro anima e corpo si dissolvono per tornare immediatamente in vita nella morte stessa. Lasciamo ai numerosi ammiratori di Rahner immaginare o spiegare come sia possibile o pensabile una cosa del genere. Questo ci dice a che punto di soggezione acritica può giungere l’ammirazione per un teologo, anche se certamente non privo di qualità.
Abbiamo qui nel famoso teologo tedesco un nodo di incresciosi equivoci che occorre dissipare. Innanzitutto. Quando si parla, nella teologia cattolica tradizionale, di “dopo la morte” (post mortem), quel “dopo”, come ho già detto in una lezione precedente, non va inteso in senso temporale, ma come durata “eviterna” o, per usare un termine dotto, “aiònica” (dal greco aiòn, da cui il termine “eone”, latino aevum, italiano evo, ebraico olàm), che è la durata propria delle sostanze spirituali finite (anime ed angeli). Il che non impedisce che l’anima separata, vivente in una dimensione ultraterrena, abbia rapporto con la temporalità di questo mondo.
Infatti noi su questa terra possiamo benissimo misurare con la categoria della temporalità la durata aionica delle anime viventi nell’al di là. Se per esempio S.Teresa di Gesù Bambino è morta nel 1897, possiamo dire benissimo che ella è in paradiso da 104 anni. Per questo nella pratica delle indulgenze si stabiliscono delle durate temporali, che però vanno intese non in modo univoco alla durata delle anime del purgatorio, ma semplicemente analogo, il che però non ci impedisce affatto di concepire durate più o meno lunghe di permanenza in purgatorio. Infatti le preghiere o le SS.Messe possono accorciare le pene del purgatorio o anche toglierle del tutto.
In secondo luogo Rahner si fa forte del fatto che per l’antropologia biblica l’uomo è un’unità di anima e corpo. Da qui la sua teoria che questa dualità è inscindibile: o sta intera, o cade intera. Resta però il fatto che Rahner, con questa teoria che va attentamente precisata – cosa che Rahner non fa -, si oppone all’evidenza del fatto della morte, nel quale si ha invece una separazione dell’anima dal corpo.
Rahner dunque confonde l’unione di diritto dell’anima col corpo con un’inesistente unione di fatto, che viene dimostrata alla morte. Egli allora è costretto a inventare un altro corpo, distinto dalla salma giacente nel sepolcro, per giustificare la sua teoria della resurrezione “nella morte”, impigliandosi in una serie di gravi inconvenienti che non è il caso qui di elencare e che lo portano fuori dell’ortodossia cattolica.
In base alle precedenti considerazioni è del tutto legittimo e doveroso mantenere la tradizionale e gravissima questione del destino dell’uomo dopo la morte, mentre il parlare, come fa Rahner, di un’eternità nella stessa morte, ha tutto l’aspetto di una visione morbosa ed assurda di una coesistenza della morte con la vita, che fa venire in mente certe antiche concezioni cicliche (morte–vita) gnostiche o l’esoterismo tenebroso della massoneria. La stessa svastica nazista era appunto il simbolo di quest’unione indissolubile (la croce a “ruota”) della vita con la morte, contrariamente alla visione cristiana che aspira ad una vita immortale.
Diciamo pertanto con tutta franchezza, seguendo l’insegnamento divino della nostra fede, che il cristiano si attende dopo la morte e per l’eternità di vivere una vita beata – quello che tradizionalmente si chiama “paradiso” -, che consiste, come ebbe a definire dogmaticamente Benedetto XII nel 1336, nella visione intellettuale immediata ed intuitiva, “facciale”, secondo il “faccia a faccia” di biblica memoria, dell’“essenza divina” del Dio Trinitario o, come si esprime la stessa Bibbia, il “volto” di Dio.
Si tratta della cosiddetta “visione beatifica”, accessibile all’anima già immediatamente da dopo la morte, se essa è dovutamente purificata da ogni traccia di peccato; diversamente, sempre secondo la fede cattolica, essa dovrà trascorrere una certa durata di eviternità in un luogo ultraterreno di purificazione, detto “purgatorio”, prima di essere ammessa alla visione di Dio.
Il raggiungimento della visione beatifica è dono della grazia(1) e in particolare dono della perseveranza finale, ma anche al contempo libera scelta dell’uomo nell’istante della morte(2), allorchè si presenta davanti al giudizio divino, poiché, in forza del suo libero arbitrio, l’uomo, per un atto di implacabile orgoglio, ha anche la possibilità di rifiutare quest’ultima offerta che Dio gli fa della sua misericordia, per cui viene giustamente castigato con una pena eterna, tradizionalmente chiamata pena dell’inferno.
Ovviamente, mentre il libero consenso alla divina offerta è effetto della grazia e merito dell’uomo, il rifiuto è esclusivamente colpa dell’uomo, dato che Dio dà a tutti la possibilità di salvarsi, solo che lo vogliano. Per questo la Chiesa ha condannato come orribile bestemmia il pensare, come hanno osato fare alcuni, che Dio non predestini solo al paradiso ma anche all’inferno.
Dunque il paradiso è ad un tempo dono gratuito della grazia e merito dell’uomo. L’apparente contraddizione tra questi due fatti, contraddizione nella quale s’impigliò Lutero negando il merito in nome della grazia (sola gratia), si risolve tenendo conto del fatto che, come insegna il Concilio di Trento, lo stesso merito soprannaturale, necessario per ottenere il paradiso, è dono della grazia. Vano invece sarebbe lo sperare l’eterna beatitudine in base a meriti semplicemente umani, perché non c’è proporzione fra ciò che l’uomo può meritare con le sue semplici forze naturali e il bene soprannaturale della visione beatifica, per ottenere il quale occorre sì il merito, ma sostenuto dalla vita della grazia divina.
Perché la beatitudine dell’uomo consiste nella visione di Dio? Perché l’effetto di una causa trova la sua perfezione nella sua congiunzione con la causa. Ora l’esistenza dell’uomo è effetto della potenza creatrice divina. E pertanto l’uomo trova la sua massima felicità nel congiungersi perfettamente a Dio, causa prima, bene sommo, infinito ed eterno. E tal congiunzione avviene con le potenze dello spirito, intelletto e volontà, perché Dio è purissimo spirito.
La volontà aspira al bene concepito dall’intelletto. Sommo desiderio di questi è la contemplazione della verità assoluta. Ora Dio è appunto la Verità assoluta. Per questo l’intelletto, nel vedere Dio “faccia a faccia”, è sommamente beato. Ma per la piena beatitudine non basta l’atto dell’intelletto, occorre la volontà, la quale, nell’amore e nella fruizione, si unisce realmente al bene desiderato e gode del suo possesso. Anzi si può dire con S.Bonaventura che, se la beatitudine è un godimento e questi, come atto dell’affetto, dipende dalla volontà, la beatitudine consiste soprattutto nella congiunzione della volontà con Dio o quanto meno, per restare più vicini alla visione tomista, che la volontà è il compimento della beatitudine, la cui sostanza sta già nell’atto della visione beatifica.
Da tener presente che la beatitudine si raggiunge dopo la morte non perché, come pensava Platone, il corpo sia di ostacolo al conseguimento della beatitudine, per cui per raggiungerla, bisognerebbe “liberarsi” dal corpo, ma perché nella vita presente, se è possibile unirsi immediatamente a Dio mediante la carità, l’intelletto non può vedere immediatamente l’essenza divina, ma conosce Dio solo mediante le creature (il proprio io, il mondo, la Chiesa, il libro della Sacra Scrittura). Ma quaggiù il corpo è necessario per raggiungere quella vita di grazia che sin da adesso congiunge l’anima a Dio, seppur imperfettamente.
La felicità dell’uomo però non tocca solo l’anima, ma richiede anche il corpo, perché la natura umana è un composto di anima e corpo. Per questo, dopo la morte l’anima separata dal corpo può sì godere dell’eterna beatitudine, ma solo da un punto di vista oggettivo (che poi è il più importante), non però da un punto di vista soggettivo. O in altre parole: l’oggetto della beatitudine, Dio, è certo inteso dall’intelletto e dalla volontà, il che costituisce la sostanza della beatitudine; tuttavia il soggetto fruente, ossia l’uomo, non è completo in quanto anima separata, perché manca il corpo. Ecco che allora la pienezza non solo oggettiva ma anche soggettiva della beatitudine è data dal fatto che anche il corpo a modo suo partecipa dell’unione dell’anima con Dio.
Il fatto che la beatitudine si ottenga solo dopo la morte ci ricorda il mistero della croce e cioè che la croce di Cristo e la nostra partecipazione alla sua croce sono i mezzi necessari per ottenere la salvezza e quindi la visione beatifica. Per questo, se il Regno di Dio inizia già da quaggiù, come abbiamo visto nelle lezioni precedenti, tuttavia, come ci insegna Cristo, è solo accettando la nostra croce quotidiana che noi possiamo aver certa speranza di entrare in paradiso.
Bologna, 19 settembre 2011
NOTE
1 – Grazia che è offerta a tutti, anche ai bambini che muoiono senza il battesimo, i quali, come lascia intendere il Catechismo della Chiesa Cattolica, si salvano per questa sola grazia, benchè la Chiesa continui a raccomandare il battesimo per i bambini.
2 – Qui ci riferiamo a tutti gli uomini di buona volontà, appartenenti a qualunque religione o anche non religiosi, purchè credenti almeno implicitamente in Dio (Vaticano II) e che senza loro colpa non conoscono il vangelo (Beato Pio IX).




